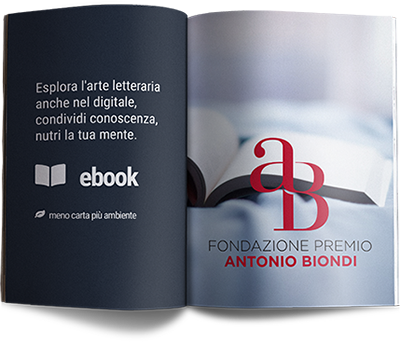EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Il tatto, il senso dimenticato che ci definisce
La pandemia e il #MeToo hanno ridefinito il nostro rapporto con il tatto, tra paura del contatto e necessità di una sua riscoperta.
Dal tatto dipende il nostro benessere, la nostra comunicazione e persino la nostra identità culturale, un senso da riscoprire.
La nostra percezione del mondo si basa su un delicato equilibrio tra i sensi. Se dovessimo rinunciare a uno di essi, la risposta più comune sarebbe il tatto. La vista e l’udito appaiono indispensabili, eppure il contatto fisico è una parte fondamentale della nostra esistenza. Il calore di un abbraccio, una stretta di mano, il semplice sfiorare un oggetto: ogni gesto attiva connessioni profonde che influenzano il nostro benessere. Il tatto non è solo un senso, ma un legame invisibile che ci unisce agli altri e al mondo circostante.
Il valore nascosto del contatto
Sottovalutato e spesso dato per scontato, il tatto ha un ruolo essenziale per la salute fisica e mentale. La sua mancanza può generare stress, aumentare la pressione arteriosa e indebolire il sistema immunitario. Tuttavia, la consapevolezza di questa verità arriva spesso solo quando il contatto fisico ci viene negato. È quello che è successo durante la pandemia, quando il distanziamento sociale ci ha costretti a ridefinire il nostro modo di relazionarci.
L’isolamento e la perdita del tatto
Nel 2020, il Covid-19 ha imposto una separazione fisica forzata: lockdown, mascherine, distanza di sicurezza. Il tatto è diventato un rischio, e il mondo ha riscoperto il significato della solitudine. L’antica filastrocca "Si guarda, ma non si tocca" è tornata prepotentemente d’attualità, rendendo evidente quanto fosse naturale e istintivo il contatto fisico.
Questo distacco forzato ha ispirato il saggio Storia naturale del tatto di Laura Crucianelli, docente di Neuroscienze cognitive alla Queen Mary University of London. L’autrice esplora come la pandemia abbia generato una sorta di fobia del contatto, estendendosi anche agli oggetti di uso quotidiano. Maniglie, libri, strette di mano: gesti normali sono diventati fonte di ansia, un fenomeno che in molti casi persiste ancora oggi.
Dal #MeToo alla diffidenza verso il contatto
Ma la pandemia non è stata l’unico evento a ridefinire il nostro rapporto con il tatto. Il movimento #MeToo ha portato alla luce il problema degli abusi di potere attraverso il contatto fisico, ridefinendo i confini di ciò che è accettabile. Figure professionali come medici, insegnanti e terapeuti hanno dovuto ripensare il proprio modo di interagire, riducendo il contatto fisico al minimo. In questo contesto, il tatto è diventato un argomento delicato, al punto che si è sviluppata una vera e propria "etichetta del contatto".
Nel frattempo, il mondo digitale ha reso il tatto quasi superfluo. I device touchscreen ci permettono di interagire con la tecnologia in modo immediato, e l’uso dei comandi vocali sta eliminando persino il bisogno di sfiorare uno schermo. Eppure, il nostro linguaggio conserva espressioni come "avere tatto" o "ci vuole tatto", a dimostrazione di quanto questo senso sia profondamente radicato nella nostra cultura e comunicazione.
Il tatto, una riscoperta necessaria
Nonostante tutto, il tatto sta vivendo una rivalutazione. Il Nobel per la medicina del 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro ricerche sui recettori del tatto e della temperatura. La loro scoperta ha evidenziato che il tatto non serve solo a percepire il caldo, il freddo o le superfici, ma è essenziale per la nostra interazione con il mondo e per il senso di appartenenza a una comunità.
Diversi studi confermano che la frequenza del contatto fisico varia in base alla cultura. A Porto Rico, le coppie si toccano in media 180 volte all’ora, a Parigi 110, in Florida appena due, mentre a Londra quasi mai. Anche nelle relazioni sociali e familiari, gli italiani dimostrano di essere più inclini al contatto rispetto ai nord-europei e agli americani. Una differenza che si nota nei piccoli gesti quotidiani, nei film e nelle interazioni con i turisti.
Il futuro del tatto nella società moderna
Il cinema ha saputo catturare questa dimensione. Nel film Diamanti di Ferzan Ozpetek, il tatto diventa protagonista attraverso i tessuti: il mikado, il raso, il damasco. Un racconto che celebra la sensualità del contatto e il suo ruolo nella nostra esperienza sensoriale. Laura Crucianelli parla di una possibile "rinascita del tatto", un recupero dopo una lunga fase di proibizionismo.
Anche nella letteratura recente, il tatto assume un ruolo centrale. Han Kang, vincitrice del Nobel per la letteratura nel 2024, nel suo romanzo L’ora di greco esplora il valore del contatto attraverso la storia di un’insegnante che, mentre perde la vista, scopre il mondo attraverso il tatto.
Lo psicologo Claudio Risé ha analizzato il ruolo del tatto nel libro Guarda, Tocca, Vivi, sottolineando come la pelle rappresenti il confine tra noi e il mondo. Il tatto non è solo una questione di piacere o sensibilità, ma un vero e proprio strumento di comunicazione. La sua perdita ci priva di una parte della nostra umanità, rendendo più difficile persino scegliere un frutto maturo al mercato.
Edonismo tattile e nuovi bisogni
La crescente digitalizzazione ci ha privati di esperienze tattili, generando un bisogno di recuperarle. Il successo delle spa, dei massaggi e delle creme idratanti risponde proprio a questa necessità di contatto. Elena Aceto di Capriglia, fondatrice di Miamo, sostiene che prendersi cura della pelle sia un modo per ritrovare il proprio equilibrio interiore.
Amanda Bell, make-up artist di Pixi Beauty, parla di "edonismo tattile" per descrivere il ritorno dell’attenzione alle texture e alle sensazioni, una tendenza che caratterizzerà il 2025. L’uso di oli che diventano creme e rossetti che cambiano tonalità dimostra quanto il tatto stia tornando a essere centrale anche nella cosmetica.
Il ritorno del bisogno di contatto
Ogni privazione genera una reazione. In molte città, dai cat café ai centri dedicati agli abbracci, il bisogno di contatto è diventato una vera e propria esigenza. A Londra, esistono luoghi dove le persone possono ricevere abbracci privi di qualsiasi implicazione sessuale, solo per il piacere di un contatto umano.
Il mondo digitale non potrà mai sostituire del tutto il calore umano. Laura Crucianelli invita a una riflessione: "Usate il touch con le persone, non solo con i display". Un consiglio che vale la pena ascoltare, per non perdere di vista (e di tatto) ciò che ci rende veramente umani.
05 Marzo 2025 © Redazione PANTAREI Fondazione Premio Antonio Biondi

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.