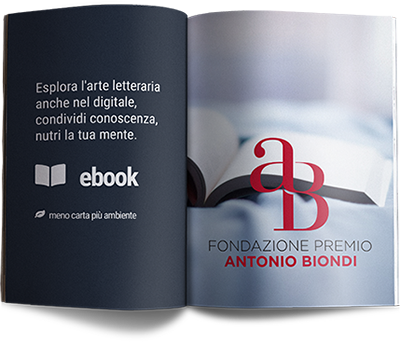EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
San Pietro in Vincoli
Il Mosè di Michelangelo
Se vi capita di stare vicino al Colosseo, da Via dei Fori Imperiali a metà di Via Cavour sulla destra si
trova la Scalinata di Via San Francesco di Paola.
Più conosciuta per essere la scalinata che porta alla storica sede della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, si arriva ad una Piazza dove troviamo la Chiesa di San Pietro in Vincoli, ricostruita sui
ruderi di una chiesa preesistente chiamata Ecclesia Apostolorum (Chiesa degli Apostoli), conosciuta
anche come Basilica Eudossiana, fatta costruire nel V secolo (442 d.C.) dall’Imperatrice Licinia
Eudossia, moglie di Valentiniano III e figlia di Teodosio II, Imperatore d’Oriente.
Si narra che la madre di Licinia Eudossia, Elia Eudocia, ebbe in dono da Giovenale, il Patriarca di
Gerusalemme, le catene che avevano tenuto legato San Pietro quando fu imprigionato a
Gerusalemme.
Le mandò alla figlia che decise di regalarle a Papa Leone Magno che già possedeva le catene usate per
incatenare San Pietro nel Carcere Mamertino e sembra che quando le catene furono messe vicino si
fusero in un’unica catena: per ricordare questo miracolo fu edificata la chiesa che venne chiamata in
vincula (catene in latino) e tutt’oggi sotto l’altare maggiore il 1° agosto di ogni anno sono visibili ai
fedeli.
A parte la reliqua e altre importanti opere ̶ sotto il pavimento della navata centrale furono portate alla
luce una serie di edifici sovrapposti appartenenti a Domus aristocratiche di età repubblicana ed
imperiale, due case risalenti alla fine del II secolo a.C. e una grande Domus probabilmente del periodo
neroniano appartenente alla Domus Transitoria o alla Domus Aurea, ci sono poi una tela del Guercino
(Sant’Agostino) e due dipinti del Domenichino ̶ la chiesa è famosa per ospitare uno dei capolavori
dell’arte rinascimentale: dal 1545 vi è custodito il Mosè di Michelangelo Buonarroti, scolpito per
ornare il monumento funebre di Papa Giulio II.
Questa di San Pietro in Vincoli non sarebbe stata la prima statua fatta da Michelangelo: aveva già
avuto un sacco di incarichi da collezionisti e da cardinali per realizzare loro un’opera importante.
Fra questi, ci fu Papa Giulio II (Giuliano della Rovere), a cui si deve la fondazione dei Musei Vaticani,
che conoscendo molto bene Michelangelo Buonarroti, decise di affidargli un incarico unico: costruire
la sua tomba che doveva essere un’opera imponente (si pensi che solo il Mosè è una statua alta 235
centimetri!).
Quando gli fu commissionato il monumento nel 1505, Michelangelo passò 8 mesi a Carrara alla
ricerca dei blocchi di marmo perfetti, ma al suo ritorno a Roma, il Papa era interessato alla
costruzione della Volta della Cappella Sistina, a cui Michelangelo lavorò tra il 1508 ed il 1512, e quindi
il progetto della tomba fu rimandato.
Michelangelo rimase così deluso che parlò di quanto accaduto come di una “tragedia della sepoltura”.
Purtroppo, Papa Giulio II morì nel 1513 quando il progetto non era ancora stato terminato e visto che
un lavoro così importante non poteva essere bloccato, furono gli eredi di Giulio II a decidere di
continuare a lavorare su un progetto che però nel 1516 venne modificato e ridotto notevolmente:
Michelangelo completò solo il Mosè ed i “Prigioni” mentre al resto del Mausoleo lavorarono gli allievi
del Maestro, che fecero una semplice facciata con sei nicchie per le statue al posto del progetto
iniziale che prevedeva una tomba con 40 statue.
I “Prigioni”, un gruppo di sei statue di figure incatenate in varie pose come prigionieri, oggi sono nella
Galleria dell’Accademia a Firenze (i quattro non-finiti) e nel Museo del Louvre a Parigi (i due quasi-
finiti).
L’opera fu realizzata dal 1513 al 1542; come oggi la vediamo, ai lati del Mosè ci sono la
Personificazione della Vita Attiva (Lia) e la Personificazione della Vita Contemplativa (Rachele), opere
queste che furono completate da Raffello di Montelupo, sopra il Mosè troviamo la statua giacente
di Giulio II, a lungo attribuita a Maso del Bosco, anche se dopo gli ultimi restauri si pensa invece essere
opera dello stesso Michelangelo, a sinistra una Sibilla ed a destra un Profeta, anche esse opere di
Raffaello di Montelupo, mentre la scultura raffigurante una Madonna in piedi con il Bambino, quasi a
vegliare sul corpo del pontefice defunto, fu realizzata da Scherano da Settignano.
C’è un documento che sembra dimostrare che il lavoro di Buonarroti sia stato modificato in realtà 25
anni dopo essere stato completato: Michelangelo decise non solo di ruotare la testa del protagonista
biblico per ragioni religiose ma di aggiungere altri dettagli su tutto il corpo per rendere questo
movimento molto più naturale.
Si deve al contemporaneo Antonio Forcellino (architetto, storico dell’arte, saggista e restauratore
italiano) che ha avuto il compito di ripulire l’opera del Mosè con l’aiuto di acqua distillata e carbonato
di ammonio, la scoperta dell’autografia di Michelangelo che conferma le modifiche apportate
dall’autore in un secondo momento.
Oltre a questi studi anche altri indizi confermano la rotazione della testa di Mosè: vedendo più da
vicino, la barba sembra sia stata tirata a destra perché dall’altro lato non c’era abbastanza marmo per
farla perpendicolare come in origine.
Il corpo della statua del Mosè è stato ridefinito dopo la torsione, abbassando di 7 centimetri il trono su
cui il protagonista è seduto; per appoggiare indietro il piede sinistro di Mosè lo scultore è costretto a
stringere il ginocchio sinistro di 5 centimetri rispetto all’altro.
Inoltre, c’è un altro importante cambiamento che riguarda la cintura che si vede sul lato posteriore del
Mosè, la quale però sembra scomparire sul davanti.
Ora, riprendendo il motivo per cui il Mosè di Michelangelo ha la testa girata ci sono due possibili
risposte.
Lo psicanalista Sigmund Freud ha ipotizzato che Mosè si sia girato e si stia tirando la barba per domare
la propria passione e per salvaguardare le Tavole con i Comandamenti.
Christoph Luitpold Frommel, uno studioso di arte rinascimentale di fama mondiale, ritiene che Mosè
si sia voltato per non guardare direttamente né gli altari presenti nell’abside della chiesa e nemmeno il
transetto dove erano conservate le catene di San Pietro.
Tornando a vedere le caratteristiche di questa statua, innanzitutto Michelangelo ha realizzato un
personaggio seduto, non in piedi o in movimento come erano soliti fare gli scultori dei tempi passati:
vedendo i piedi, solo quello destro tocca completamente a terra e la gamba sinistra è sollevata in
modo tale che soltanto la punta del piede tocca la base.
Più in alto vediamo che Mosè tiene sotto il braccio le Tavole dei Comandamenti che sembra siano
rovesciate e molti studiosi hanno ritenuto che questo fosse stato un errore di Mosè.
In realtà sembra che invece siano state fatte volutamente così, dando l’impressione che stiano piano
piano scivolando dalla presa di Mosè.
Con l’altra mano regge la barba, e questo sembra un atteggiamento riflessivo, quasi di attesa; lo
sguardo è uno dei dettagli più caratteristici di questo lavoro, rende l’espressione un curioso mix tra
tensione e rabbia.
Anche le braccia e le mani fanno notare i muscoli molto tesi, come se la statua da un momento
all’altro fosse pronta a scattare nell’alzarsi liberando tutta l’energia compressa: il motivo della
possibile rabbia la troviamo nella Bibbia nel ricordare quando Mosè, sceso dal monte Sinai dopo avere
incontrato Dio, trova il suo popolo – che aveva guidato lontano dalla schiavitù da parte degli egizi – che
in sua assenza aveva cominciato ad adorare un falso idolo, cioè il Vitello d’oro.
Mosè rimane stupefatto: con tutta la fatica e l’aiuto che aveva ricevuto da parte di Dio i suoi uomini
avevano creato un culto indipendente, ed ecco sorgere in lui una tale rabbia che prende e distrugge le
Tavole dei Comandamenti scagliandole per terra e lui stesso si getta contro il Vitello d’oro e lo
distrugge.
Questo è il motivo per cui vediamo che Michelangelo ha voluto immortalare il momento esatto in cui
Mosè sta per liberare tutta la sua rabbia e si trattiene solo perché è una statua!
Vediamo ora le corna che spuntano sulla testa del Mosè: c’è una traduzione latina della Bibbia
intitolata Vulgata in cui c’è un passaggio (Esodo, capitolo 34, versetto 29, 30 e 35) in cui viene narrato il
ritorno di Mosè dal suo popolo dopo aver ricevuto i Comandamenti da Dio e lì è anche riportato che
Mosè ha un paio di corna sulla testa e probabilmente si tratta di un errore di traduzione.
Ma questo fraintendimento non lo troviamo soltanto nella Vulgata ma anche nella Bibbia Douay-
Rheims (ovvero la traduzione inglese della Vulgata), in cui c’è scritto “… e quando Mosè scese dal
monte Sinai aveva due tavolette come testimonianza e non sapeva che la sua faccia era cornuta dalla
conversazione con il Signore”.
Anche nel testo masoretico (il libro ufficiale degli ebrei) viene raccontata la stessa storia e spunta il
termine Keren, che significa “corno, basato sulla radice”, ma forse ci si è confusi con Karan o Karnaim
che poteva essere tradotto con “due raggi della Divina Sapienza sulla fronte”.
Un commentario di Ezechiele ha scritto che la faccia di Mosè era glorificata: questa in ebraico è una
parola che viene usata anche per cornuta.
Infine, c’è la versione dei Settanta (edizione in greco di un testo biblico ebraico molto antico e con
qualche differenza da quello tradizionale) in cui c’è scritto che “Mosè non sapeva che l’apparenza
della pelle della sua faccia era glorificata”.
Quindi il nostro Mosè ha le corna per via di un errore di traduzione nel Medioevo che non è stato
corretto se non nel Rinascimento, e non fu solo Michelangelo a realizzare la statua con questa
caratteristica: altri Mosè “cornuti” possono essere visti per esempio anche sulle vetrate della
cattedrale di Chartes, di Sainte-Chapelle e di Notre-Dame.
Riprendendo quanto fu detto dallo psicanalista Sigmund Freud sul significato di questa statua,
torniamo al momento in cui il Mosè scolpito da Michelangelo è appena sceso dal monte Sinai, ha visto
Dio e ha ricevuto i dieci Comandamenti, e ha visto il suo popolo che sta adorando il Vitello d’oro: per
lui il Mosè di Michelangelo ha un’espressione agitata perché appunto si è accorto che il suo popolo sta
adorando un nuovo idolo e pochi secondi dopo in un impeto di rabbia distruggerà le Tavole dei
Comandamenti.
Ma ricordiamoci che cosa voleva fare in realtà Michelangelo: per la tomba di un Papa importante
come Giulio II è logico che non si può accettare un simbolo di ira sul suo Sepolcro: quindi, quello che
ha immortalato Michelangelo è un Mosè che è seduto e con pazienza sta controllando la sua rabbia,
con difficoltà la contiene perché non può rovinare tutto, i Comandamenti sono fondamentali nella sua
missione.
Mentre sta riflettendo però non si rende conto che le tavolette stanno scivolando dalla sua mano e
cadranno da un momento all’altro, Mosè è troppo preso dall’incarico che Dio gli ha affidato e perciò
ora deve diventare il guardiano della tomba di Papa Giulio II: le linee che secondo Freud si vedono sul
volto del personaggio rappresentano la sua vittoria contro la rabbia, nella parte centrale della statua i
muscoli in particolare mostrano gli ultimi istanti del suo tentativo di sopprimere l’impulso rabbioso
contro gli infedeli.
E per ultimo soprattutto sul piede che non è appoggiato completamente a terra si vede come se un
secondo prima avesse voluto scagliarsi con tutta la forza contro gli adoratori del Vitello d’Oro.
L’accarezzarsi la barba simboleggia la tranquillità che ha avuto la meglio sugli istinti aggressivi.
Anche altri due esperti, Malcom MacMillan e Peter Swales, hanno scritto un saggio sul Mosè del
Buonarroti: per loro questa statua è legata agli eventi narrati nel libro dell’Esodo 33-34, con Mosè che
ha sotto una mano delle tavolette vuote perché Dio ha ordinato a Mosè di fabbricare delle altre
tavolette dopo la distruzione delle prime; per quanto riguarda le corna dicono che di un Mosè cornuto
si parla all’interno della Bibbia a seguito del suo secondo viaggio di ritorno dagli ebrei dopo la discesa
dal Monte Sinai.
Inoltre, Michelangelo ha rappresentato Mosè nell’istante in cui sta per vedere Dio ed ha
un’espressione dubbiosa perché non sa se Dio sarà soddisfatto del suo comportamento e di quello
del suo popolo e se Dio li perdonerà e li guiderà alla Terra promessa: tutto quello che può fare è
prendere coraggio e chiedere a Dio di rivelare la sua gloria ed è questo il momento in cui Michelangelo
rappresenta Mosè nel preciso istante in cui è pensieroso ed in attesa dell’arrivo di Dio.
Un’ultima curiosità: su un ginocchio si nota una lieve linea di frattura legata ad una famosissima
leggenda secondo la quale, essendo il Mosè talmente “vivo”, Michelangelo avrebbe colpito la statua in
quel punto con il mazzuolo gridandogli: “Perché non parli?”.
Maggio 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.