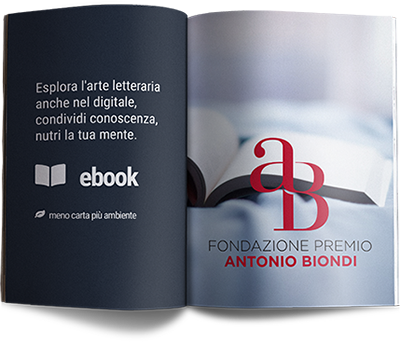EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Roma e il Giubileo
Aperta la prima Porta Santa il 24 dicembre 2024
Con l’apertura della prima delle quattro Porte Sante (una per ogni Basilica romana), cioè quella di San
Pietro, avvenuta il 24 dicembre 2024, è iniziato il Giubileo (il ventisettesimo nella storia), detto anche
Anno Santo, che finirà il 6 gennaio 2026.
L’apertura della Porta Santa è il primo rito (la cui origine sembra, da fonti ufficiali, essere iniziata per
mano di Papa Alessandro VI nel 1500) che esprime simbolicamente il concetto di offrire ai fedeli un
“percorso straordinario” verso la salvezza: la Porta viene aperta solo in questa occasione e verrà
richiusa e murata al termine, rimanendo così fino al prossimo Giubileo.
Fino al 2000, la Porta veniva smurata parzialmente prima della celebrazione, lasciando un diaframma
di mattoni che il Papa rompeva con un martelletto al momento dell’apertura ufficiale con gli operai
pronti a terminare l’operazione; Papa Giovanni Paolo II introdusse il nuovo rito, ovvero la rimozione in
anticipo del muro e quindi l’apertura che avviene solo spingendo i battenti, visto quanto accadde a Papa
Paolo VI nel 1975 che venne sfiorato da alcuni calcinacci.
Le altre Porte Sante, che ricordiamo essere a San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San
Paolo fuori le Mura, sono state aperte nei giorni successivi e tali rimarranno (a parte la chiusura
notturna) fino al termine dell’Anno Santo, per essere nuovamente murate.
Quest’anno c’è stata una prima e unica Porta Santa extra della storia, quella aperta il 26 dicembre 2024
nel giorno di Santo Stefano nel Carcere romano di Rebibbia, per seguire l’appello ai governanti di tutto
il mondo a concedere forme di amnistia e condoni di pena a tutti i reclusi che, come sottoscritto già dal
Vaticano, dal ministero di Giustizia e dal Comune di Roma, avendone i requisiti e presentando apposita
richiesta, potranno ottenere dei permessi speciali per essere impegnati in “lavori socialmente utili”.
Per la Chiesa cattolica, il Giubileo è l’anno della remissione dei peccati e delle pene per i peccati, della
riconciliazione tra i contendenti, della conversione e della penitenza sacramentale e, di conseguenza,
della solidarietà, della speranza, della giustizia, dell’impegno al servizio di Dio nella gioia e nella pace
con i fratelli; è l’anno di Cristo, portatore di vita e di grazia all’umanità.
Il Giubileo ha origine dalla tradizione ebraica che fissava, ogni 50 anni, un anno di riposo della terra
(con lo scopo pratico di rendere più forti le successive coltivazioni), la restituzione delle terre
confiscate e la liberazione degli schiavi, questo affinché non ci fosse comunque il troppo ricco o il
troppo povero.
Per segnalare l’inizio del Giubileo si suonava un corno di montone, in ebraico jobel (in realtà caprone),
da cui deriva il termine cristiano Giubileo.
Si dice “Anno Santo” non solo perché si inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri ma anche
perché è destinato a promuovere la santità di vita.
Il Giubileo può essere ordinario, quando cade periodicamente, oppure straordinario se proclamato per
eventi eccezionali.
Del Primo Giubileo e della “Indulgenza dei Cento Anni” si parla in fonti del 24 dicembre 1299, quando
masse di pellegrini si mossero verso Roma perché a conoscenza di una leggendaria “Indulgenza
Plenaria” che si sarebbe ottenuta a Capodanno del secolo nuovo, arrivando nella Basilica di San
Pietro per ottenere la remissione completa di tutte le colpe.
Nessuno, tra Papa e prelati, sapeva di questa usanza, ma memorie del cardinale Jacopo Caetani degli
Stefaneschi nel documento De centesimo sive Jubileo anno liber parlano di un vecchio di 107 anni
che, dietro richiesta di Papa Bonifacio VIII, raccontò che cento anni prima, il primo gennaio 1200,
quando aveva 7 anni assieme al padre si era recato davanti a Papa Innocenzo III per ricevere
l’Indulgenza dei Cento Anni, e questa rimane l’unica fonte certa.
Eventi simili documentati sono l’Anno Santo Giacobeo, quando Papa Callisto II nel 1126 onorò
l’apostolo San Giacomo, venerato a Santiago di Compostela, una delle maggiori mete di pellegrinaggio
del mondo cristiano, e il Perdono di Assisi, nel 1216, con Papa Onorio III che su richiesta di San
Francesco stabilì che chiunque avesse visitato tra il mezzogiorno del 1° agosto e la mezzanotte del 2
agosto la Porziuncola avrebbe ricevuto l’Indulgenza Plenaria.
Ci fu poi la Perdonanza Celestiniana, nel 1294: Papa Celestino V emanò la Bolla pontificia Inter
sanctorum solemnia (Bolla del Perdono) e concesse l’Indulgenza Plenaria a chiunque, confessato e
comunicato, fosse entrato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila dai Vespri del 28
agosto a quelli del 29 agosto.
Questa Perdonanza ha in comune con il Giubileo l’indulgenza in cambio del pellegrinaggio.
Fu quindi ufficialmente Papa Bonifacio VIII, dopo Papa Celestino, a istituire il primo Giubileo con la
Bolla del 22 febbraio 1300 (che in realtà in quei tempi era ancora 1299, con il capodanno che secondo
l’uso ab incarnatione cadeva il 25 marzo) Antiquorum habet fida relatio, facendo riferimento alla
suddetta Indulgenza dei Cento Anni: l’Indulgenza Plenaria veniva concessa a tutti coloro che avessero
visitato trenta volte se romani e quindici volte se stranieri le Basiliche di San Pietro e di San Paolo fuori
le Mura durante tutto il 1300, e l’evento si sarebbe ripetuto ogni cento anni.
In quel periodo di odio e di violenza si diffuse un’ondata di spiritualità, di perdono e di fratellanza che
coinvolse il mondo cristiano; tra i pellegrini di questo primo Giubileo ci furono Dante, Cimabue, Giotto
e Carlo di Valois, fratello del re di Francia, con sua moglie Caterina.
Dante Alighieri ne parla in alcuni versi del Canto XXXI del Paradiso della Divina Commedia, mentre nel
Canto XVIII dell’Inferno addirittura dice che ci furono così tanti pellegrini da dover regolamentare il
senso di marcia dei pedoni sul ponte di fronte a Castel Sant’Angelo…
Nel 1350 Papa Clemente VI accorciò la distanza di 50 anni tra un Giubileo e l’altro, pari al Giubileo
ebraico (il particolare di questo Giubileo fu l’assenza del Papa a Roma, che rimase ad Avignone per le
avverse condizioni politiche del momento); fu aggiunta alle due Basiliche da visitare quella di San
Giovanni in Laterano, la cui apertura della Porta Santa però avvenne nel Giubileo del 1425, stesso
anno in cui fu coniata una speciale medaglia commemorativa.
L’intervallo da 50 scese a 33 anni con Papa Urbano VI (come l’età di Cristo sulla terra) ed infine a 25
anni con Papa Paolo II.
Ci furono dei Giubilei “ricordati” per motivi particolari: nel 1450, ci fu il Giubileo detto dei Santi vista la
presenza fra i pellegrini di alcune figure importanti della Chiesa che poi sarebbero divenuti Santi,
come Giovanni da Capestrano, Pietro Regalado, Diego d’Alcalà e Caterina da Bologna, ma fu anche
detto Giubileo d’Oro per l’afflusso di ingenti somme di denaro con cui Papa Niccolò V si prodigò in
opere di mecenatismo; nel 1475 Papa Sisto IV volle abbellire Roma, facendo costruire importanti
opere tra cui la Cappella Sistina ed il Ponte Sisto sul Tevere; nel 1525, vista la ribellione di Martin
Lutero, il Papa tolse l’obbligo dell’elemosina per i partecipanti ai riti di Roma.
Nel 1600 Papa Clemente VIII decise di servire personalmente i 12 poveri che ogni giorno venivano
scelti come ospiti alla sua mensa; nel 1650 Papa Innocenzo X nominò come direttrice dei lavori
giubilari Olimpia Pamphili, la cognata, protagonista nelle cerimonie pubbliche; il Giubileo del 1700 fu
aperto da Papa Innocenzo XII e chiuso da Papa Clemente XI perché nel frattempo il primo Papa era
morto.
Nel 1875, dopo la dissoluzione dello Stato Pontificio avvenuta nel 1870, Papa Pio IX non aprì la Porta
Santa, ignorò la città ed i pellegrini ed evitò i cerimoniali, vista la sua “autoreclusione” nei Palazzi
Vaticani: sembra che le forze avverse al Papa organizzarono a Roma il “Giubileo dei folli”, con uomini e
donne vestiti da cardinali e guardie svizzere che inscenarono una processione blasfema per deridere il
Corpus Domini.
Quello del 1925 fu chiamato Giubileo della Pace, in quanto era da poco finita la Prima guerra mondiale
e Papa Pio XI fu chiamato il Papa missionario visto che ogni giorno parlò ai pellegrini, mentre quello del
1950 fu chiamato da Papa Pio XII “L’anno del grande ritorno e del grande perdono” visto i disastri
causati dalla Seconda guerra mondiale: la “Carta del pellegrino” rilasciata in quell’anno fu
riconosciuta pari ad un passaporto per l’Italia per favorire l’arrivo dei pellegrini.
Altri Papi proclamarono Giubilei straordinari al di fuori di questa scadenza: l’ultimo fu quello del 2015,
il Giubileo straordinario della Misericordia, proclamato da Papa Francesco a 50 anni dalla fine del
Concilio Vaticano II con inizio l’8 dicembre 2015 e fine il 20 novembre 2016; fu un Giubileo particolare
che ha visto per la prima volta presenti un Papa regnante ed un Papa emerito, in quanto all’apertura
della Porta Santa partecipò anche Papa Benedetto XVI che attraversò la Porta dopo Papa Francesco
ma prima degli altri.
In questo Giubileo fu aperta per la prima volta la quarta Porta Santa, ovvero quella della Basilica di
Santa Maria Maggiore.
Papa Francesco ha anche proclamato il Giubileo straordinario lauretano dall’8 dicembre 2019 al 10
dicembre 2020, in occasione dei cento anni della proclamazione della Beata Vergine Maria di Loreto
da parte di Papa Benedetto XV come Patrona di tutti gli aviatori.
Il Giubileo prevede che i pellegrini possano seguire una serie di percorsi consigliati e diversi
pellegrinaggi all’interno di Roma: il più famoso ed antico è quello che tocca le Sette Chiese, noto sin
dal VII secolo.
Il percorso delle Sette Chiese, circa 20 chilometri, quando non ci stavano i mezzi si svolgeva in due
giorni, preferibilmente nel periodo pasquale: oltre alle quattro Basiliche maggiori, cioè San Pietro, San
Paolo fuori le Mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, si visitano le tre minori che sono
Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo e San Sebastiano e altri antichi luoghi cristiani, come le
Catacombe di Commodilla, di Domitilla e di San Callisto.
Fu San Filippo Neri, Santo molto amato dai romani anche per il suo impegno con i giovani, nel 1552 a
voler rinnovare il tracciato, aggiungendo altre tappe, e da piccoli gruppi di persone pian piano
coinvolse una grande folla di pellegrini: si partiva dalla Chiesa di San Girolamo per raggiungere la
Basilica di San Pietro dove si passava la notte, la mattina dopo si riprendeva la marcia per andare alla
Basilica di San Paolo fuori le Mura, poi a quella di San Giovanni in Laterano, a San Lorenzo, a Santa
Maria Maggiore, a Santa Croce in Gerusalemme per finire alla Basilica di San Sebastiano dove, nelle
Catacombe, nel giorno della Pentecoste del 1544, il cuore di San Filippo Neri fu colpito da
“un’effusione dello Spirito Santo”, come lo stesso Santo raccontò ai suoi fedeli.
Il numero sette del pellegrinaggio ricorre non solo per le sette chiese da visitare ma ha un significato
spirituale per ogni momento e luogo che si incontrano: vengono recitati i sette salmi penitenziali per
invocare il perdono dai sette vizi capitali, ricordando le sette principali tappe che Gesù toccò durante
la Passione, le sette effusioni del sangue di Cristo, le sette parole di Cristo in Croce, i sette doni dello
Spirito Santo, i sette sacramenti e le sette opere di misericordia.
Il pellegrinaggio, sia per il simbolismo sia per la suggestione, ebbe sin dall’inizio un’enorme eco e
tuttora sono tanti i fedeli che venendo a Roma si accingono a percorrere questo itinerario, anche a
piedi.
Per finire… salutiamo Luce, la mascotte ufficiale del Giubileo 2025, realizzata dall’illustratore romano
Simone Legno: impermeabile giallo, calosce verdi sporche di fango, capelli e occhi blu (in cui si vede
una conchiglia stilizzata, simbolo del Cammino di Santiago), bastone in mano e crocifisso al collo,
Luce è una bambina pellegrina realizzata in stile manga, quello dei fumetti giapponesi, personaggio
pensato per “riflettere la cultura pop” apprezzata dai giovani, per portare a tutti il messaggio di
“speranza e fraternità”.
Luce è stata presentata ufficialmente al Lucca Comics, la Fiera del Fumetto più importante d’Europa,
a cui per la prima volta ha partecipato un Dicastero della Santa Sede.
Gennaio 2025 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.