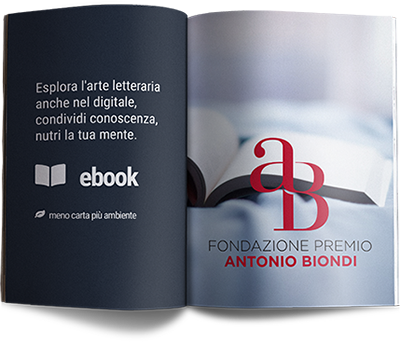EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Passaggi segreti sotto il suolo di Roma
Roma e i suoi sotterranei
Abbiamo ultimamente visto alcuni dei sotterranei esistenti sotto molte chiese romane, ma non tutti
sanno che ci sono anche dei percorsi che è possibile fare oltre a quelli nelle classiche catacombe.
Dando per scontato la conoscenza che il sottosuolo di Roma è una “groviera”, con almeno 20 metri di
distanza tra l’attuale piano di calpestio e l’originaria superficie (che risale al primo insediamento
urbano) e circa 2700 anni di storia, con una città sempre più in crescita, le frequenti alluvioni del Tevere,
gli incendi, i detriti degli edifici crollati e non smaltiti hanno nel tempo creato l’innalzamento del piano
di calpestio, tanto da rendere “sotterranee”, oltre alle strade, le dimore patrizie, le fontane, le chiese e i
mitrei.
Senza contare poi le strutture come le cisterne di acqua, gli acquedotti, le fognature, le cave da cui
venivano estratti i materiali rocciosi, e le catacombe, che già nella concezione dovevano essere
sotterranee, che sono state realizzate scavando direttamente nel tufo.
Ecco perché abbiamo tanto da conoscere: dei veri e propri “percorsi” nella storia, camminando su
strade che sia a piedi sia con l’utilizzo di biciclette ci consentono di visitare luoghi incredibili, così come
“scoprire” luoghi di cui si è formulata solo un’ipotesi di passaggi segreti.
Vorrei partire proprio dalla Passeggiata in quello che è chiamato il Labirinto di Roma, all’interno del
Parco dell’Appia Antica: lungo 5 chilometri, sono tutte gallerie, una in particolare lunga 1 chilometro e
mezzo percorribile appunto sia a piedi sia in bicicletta.
È un posto magico in cui rivivere un periodo storico che va dal I secolo d.C. ai primi del 1900.
In epoca romana, visto l’incremento demografico, si lavorò ininterrottamente per costruire opere
abitative (domus e ville) e infrastrutture (come acquedotti e fognature): queste gallerie nacquero per
fornire materiale da costruzione, specie pozzolana, e poi divennero case per le famiglie di schiavi
(molti di loro non videro mai la luce del sole), fossores (coloro che si occupavano della manutenzione
dei cimiteri e dello scavo delle catacombe) e manovali specializzati, che lavoravano giorno e notte;
queste gallerie si trasformarono nei secoli in passaggi segreti e poi in catacombe, ma anche in
scorciatoie per raggiungere mitrei, catacombe, colombari (cioè costruzioni funerarie divise in ampi
loculi, ognuno contenente una bara con un solo defunto).
Nel Medioevo queste gallerie vennero abbandonate e nel secolo scorso divennero delle fungaie, con
migliaia di sacchi dove venivano coltivati i funghi che fecero il sostentamento alimentare dei romani,
per buona parte del ‘900.
Da tanti conosciuto e finalmente di nuovo percorribile, dopo la ristrutturazione, ci sta er Coridore de
Borgo (in romanesco), cioè il Passetto di Borgo: è il “Passaggio Segreto dei Papi”, un passaggio
pedonale sopraelevato lungo circa 800 metri che collega il Vaticano con Castel Sant’Angelo, costruito
per consentire al Papa di rifugiarsi nella Mole di Adriano in caso di pericolo e ad avere con il Bastione
di San Marco più controllo del Rione.
Sembra sia stato Papa Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini) che nel 1277 fece costruire il Passetto,
utilizzando opere già esistenti durante i lavori di restauro delle Mura Vaticane, e Papa Alessandro VI
(Rodrigo Borgia) fece aggiungere un passaggio coperto, durante una massiccia ristrutturazione.
C’è chi invece dice sia stato Papa Bonifacio IX che, più di un secolo dopo, avrebbe iniziato i lavori
terminati da Baldassarre Cossa, l’antipapa Giovanni XXIII.
Durante l’invasione di Roma delle milizie di Carlo VIII di Francia nel 1494 lo stesso Papa Alessandro VI
utilizzò il Passetto per rifugiarsi a Castel Sant’Angelo, cosa che fece anche Papa Clemente VII (Giulio
de’ Medici) per nascondersi nel 1527, prima di fuggire ad Orvieto, durante il Sacco di Roma effettuato
dai lanzichenecchi di Carlo V d’Asburgo; in merito a questo attacco, durante il quale la maggior parte
della Guardia Svizzera fu massacrata, sono ancora oggi visibili i segni lasciati dai colpi di archibugio
dei mercenari tedeschi.
Nel 1565 Papa Pio IV (Giovanni Angelo Medici) ha fatto costruire le Mura di Borgo Pio, Vittorio e
Angelico, intervento che da struttura difensiva (come avvenne per contrastare i ripetuti attacchi dei
Saraceni) ha fatto divenire il Passetto un elemento urbano integrato.
Altra funzione del Passetto era quella di condurre di nascosto i detenuti alle prigioni di Castel
Sant’Angelo, come accadde per Beatrice Cenci che sembra lo abbia percorso in catene prima
dell’esecuzione nel 1599.
Per accedere al Passetto si entra dall’antichissima Porta San Pellegrino, chiusa tra due torri merlate,
ingresso quasi nascosto dal Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro: oltre ad offrire una vista
inusuale su Roma e il Vaticano, il Passetto ci offre meraviglie incredibili, come lo stemma di Papa
Alessandro VI sotto una piccola finestra, fornici (aperture arcuate) aperti in vari periodi storici e
Madonnine.
Ci sono delle curiosità in merito al Passetto di Borgo: in origine, il Passetto veniva chiamato “Lo
Andare” e si dice che Papa Alessandro VI usasse il Passetto per raggiungere gli appartamenti in cui
incontrava le sue amanti.
Da qui, la leggenda che, se si percorre settantasette volte avanti e indietro gli ottocento metri del
Passetto, ovvero una passeggiata di 60 chilometri, gli uomini possano recuperare la virilità perduta.
Infine, il vicino Vicolo delle Palline si chiama così per via delle palle che compaiono sullo stemma
mediceo di Papa Pio IV sopra l’arco sinistro dell’attuale Porta Angelica.
Arriviamo a Piazza Montecitorio, e a tutti i segreti che la riguardano, a partire dal nome: o deriva dal
leggero rilievo che contraddistingue il terreno, cioè mons, e dalle “saepta” (luoghi in cui si riunivano e
votavano le assemblee del popolo), per cui “citorio” potrebbe derivare da acceptabilis e acceptorius in
riferimento alla chiamata al voto, oppure deriva dal fatto che qui venivano accumulati materiali di
scarto (accettatorio) dai lavori di bonifica della zona adiacente, dei veri e propri acquitrini malsani, o
anche che il “mons” fosse frutto degli scavi per le fondamenta della Colonna di Antonino Pio, un
tempo presente su questo luogo.
Sulla Piazza si affaccia il palazzo sede della Camera dei Deputati: progettato da Bernini su
commissione di Papa Innocenzo X e concluso da Carlo Fontana per Papa Innocenzo XII, sulla facciata
principale c’è un campanile a vela.
I rintocchi della campana principale (che oggi suona solo quando viene eletto il Presidente della
Repubblica) segnavano l’inizio delle udienze, ma l’aspetto più curioso è che dal balcone sottostante
venivano estratti i numeri del lotto: era un orfanello, chiamato dal popolo “ruffianello”, che estraeva e
gridava i numeri ogni sabato, e tutti i romani accorrevano con la speranza di vincere.
Anche l’obelisco al centro della piazza ha una storia leggendaria e curiosa: è lo gnomone dell’orologio
di Augusto (Horologium Augusti) o Meridiana di Augusto, che è stato il segnatempo solare più grande
del mondo antico, un tempo collocato nei pressi dell’Ara Pacis.
A questo punto non possiamo non accennare a quella che forse è solo una leggenda, in quanto non ci
sono prove certe che ne affermino la realtà: sotto i palazzi del potere di Roma ci sarebbe un tunnel
segretissimo, che, collegando centri nevralgici del potere italiano e sedi militari, avrebbe consentito ai
potenti di mettersi in salvo in caso di eventi catastrofici.
Questa “strada sotterranea” a due corsie unirebbe Forte Trionfale e Forte Braschi, che fino al 2007 era
il quartier generale del SISMI (l’intelligence militare) e oggi è sede della Agenzia Informazioni e
Sicurezza Esterna (l’AISE).
Passerebbe quindi per Forte Boccea, che fino al 2005 era un carcere giudiziario militare, e correrebbe
fino al centro della città, toccando Viminale (Ministero dell’Interno), Quirinale (Presidenza della
Repubblica), Palazzo Chigi (sede del Governo e del Consiglio dei Ministri) e Montecitorio (Camera dei
Deputati e Parlamento).
Dai palazzi del potere tornerebbe verso nord raggiungendo il Ministero della Marina.
Si vocifera quindi di un’ulteriore diramazione, che da Forte Boccea giungerebbe sotterraneamente,
passando sotto Via Cassia, ad una sede – qualcuno dice un bunker – del Comando in capo della
Squadra Navale (il braccio operativo dello Stato Maggiore della Marina), mentre un’altra porterebbe
direttamente a Civitavecchia (dove sorge l’importante porto).
Dobbiamo dire che questa storia è poco chiara, raccontando di forze militari e 007 italiani pronti ad
intervenire per aiutare i potenti italiani, non solo politici, a fuggire: se ne parlò già negli anni ‘70, con il
colpo di Stato di Junio Valerio Borghese, e durante il rapimento di Aldo Moro; ci fu poi un racconto di
alcuni operai impegnati in lavori stradali in zona Trionfale che avrebbero casualmente trovato un
tunnel di cui non conoscevano l’esistenza, e che appena scesero nel passaggio si trovarono di fronte
degli uomini armati non meglio identificati che ordinarono loro di lasciare immediatamente il tunnel e
proseguire nel cantiere come se nulla fosse.
Quel che è certo è che, tornando a Montecitorio, quando costruirono il Palazzo tornarono alla luce
resti imperiali che permisero di identificare la piazza come l’area un tempo dedicata agli Ustrinum,
ovvero i luoghi dove gli imperatori e le loro famiglie si facevano cremare; proprio qui c’era quello
di Antonino Pio, di fronte al quale sorgeva la colonna a lui dedicata, il cui basamento, l’unica parte
ritrovata quasi intatta, è visibile presso i Musei Vaticani.
Ancora oggi ad ogni scavo vengono fatte scoperte, cunicoli, acquedotti ancora funzionanti, cavità
ricavate nel tufo e ricche dimore sotterranee: come già detto, circa 20 metri di sottosuolo carico
ancora di storia e di misteri.
Altri esempi di queste “sorprese” sotterranee sono la grotta e il lago di Monteverde: è un’enorme cava
per l’estrazione di tufo ed uno specchio di acqua limpida, alimentato da una fonte naturale, circa 40
metri di diametro, profondo più di 7 metri ad una distanza dalla superficie di 10 metri: si narra che
durante la Seconda guerra mondiale, gli abitanti della zona, appena suonavano le sirene si rifugiavano
qui sotto per ripararsi dai bombardamenti, stessa cosa per le cave di pozzolana che si trovano sotto il
Vittoriano, utilizzate anch’esse come rifugi antiaerei.
Ci sono poi le Cave sotto il Tempio del Divo Claudio al Celio, anche qui ci sono dei laghetti e un
percorso che si può visitare tranquillamente: si accede alle cave scendendo delle scale che portano
all’antica strada romana, dal lato occidentale del podio (180 per 200 metri) che Agrippina fece
realizzare in onore del marito, l’Imperatore Tiberio Claudio Druso, che morì avvelenato, nel 54, a causa
dei funghi cucinati dalla stessa Agrippina.
Figlio di Druso, il grande generale fratello dell’Imperatore Tiberio, è famoso per le tante opere
pubbliche che realizzò, come il completamento dell’Aqua Claudia e dell’Anio Novus, e la realizzazione
del nuovo porto presso Portus, poco più a nord di Ostia.
Sotto la Catacomba di Vigna Randanini, seconda catacomba ebraica di Roma casualmente ritrovata,
scavata nel fianco di una collina tra la Via Appia Antica e la Via Appia Pignatelli, ci sta un tunnel di
gallerie con cubicoli decorati da affreschi molto belli e i tipici kokhim, le tombe a forno che si
sviluppano perpendicolarmente alle pareti della galleria, tipiche delle zone di Israele e della Palestina.
Ricordiamo anche che sotto la Fontana di Trevi, a più di 9 metri di profondità, fu ritrovato tra il 1999 ed
il 2001, a seguito di alcuni scavi, un complesso edilizio antico: una vera e propria città, che riguarda un
periodo storico importante, dalla realizzazione dell’Aqua Virgo (Acquedotto Vergine) all’incendio di
Nerone, dal Sacco di Alarico all’assedio dei Goti.
Le strutture più antiche fanno riferimento a una insula, costruita dopo l’incendio del 64 d.C., sostituita
a metà del IV secolo da una ricca domus, una residenza destinata a persone abbienti; pur essendoci
stati saccheggi e razzie, si trovano ancora resti di un insediamento medievale.
Questa area archeologica sotto la Fontana di Trevi, nota come Vicus Caprarius, la Città dell’Acqua,
deve il suo nome al grande serbatoio idrico costruito in una parte del complesso edilizio nel II secolo
d.C., il cosiddetto castellum aquae, una cisterna che consentiva di immagazzinare l’acqua
proveniente dal vicino Acquedotto Vergine.
Incredibile pensare che questo è l’unico degli acquedotti di Roma antica rimasto ininterrottamente in
funzione fino a oggi, come dimostrato dalla Fontana di Trevi.
Infine, altri “sotterranei” da ricordare sono i bunker di Mussolini e quello dei Savoia: i primi, tre in tutto
quelli conosciuti, sono i rifugi antiaerei che Mussolini fece costruire durante la guerra: uno sotto Villa
Torlonia, uno sotto il Palazzo degli Uffici all’Eur, l’ultimo, scoperto nel 2010 durante i lavori di pulitura
di Palazzetto San Marco, un’ala di Palazzo Venezia, è rimasto incompiuto, forse per via della cattura
del Duce, era sotto terra a circa 20 metri di profondità ed erano 9 stanze nascoste da una botola di
legno.
Il bunker dei Savoia invece, restaurato recentemente anche per ospitare eventi e manifestazioni, risale
agli anni fra il 1940 e il 1942 e si trova a Villa Ada, ed è caratterizzato dal fatto di avere un ingresso
carrabile, che all’epoca permetteva di entrarvi direttamente a bordo di un’autovettura per trovare
riparo dai bombardamenti.
Questi sono solo alcuni dei tanti passaggi, segreti e non, di Roma, e sicuramente ce ne saranno
ancora talmente tanti che solo il tempo potrà piano piano rendere noti.
__
foto: Labirinto di Roma, all’interno del Parco dell’Appia Antica
Gennaio 2025 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.