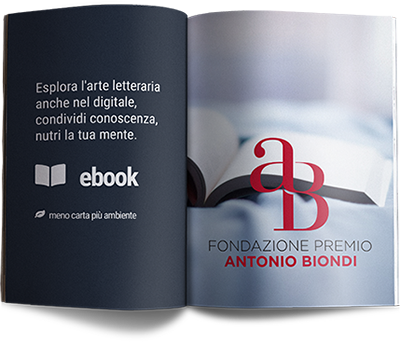EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Pasqua e i suoi simboli
La festività più importante per la Chiesa Cristiana
La Pasqua è per molti considerata la festività più importante della religione cristiana, è il giorno in
cui si celebra la Resurrezione di Gesù Cristo che ha sconfitto la morte e salvato l’umanità dal
peccato originale.
Questa festività non ha una data fissa come il Natale ma, per decisione della Chiesa, cade la
domenica successiva alla prima luna piena dopo l’equinozio di primavera.
A seconda quindi dei cicli lunari, si dice che la Pasqua è “bassa” (come quest’anno), se cade tra il
22 marzo e il 2 aprile, “media” tra il 3 e il 13 aprile, “alta” se cade tra il 14 e il 25 aprile (calcolo che
fu effettuato da Dionigi il Piccolo).
Si comincia con la Quaresima (un periodo di quaranta giorni di digiuno, preghiera e penitenza, che
ricorda i quaranta giorni che Gesù passò nel deserto) e, secondo il rito romano, inizia il Mercoledì
delle Ceneri e finisce il Giovedì Santo, ed è la preparazione che culmina con l’evento pasquale.
Il termine Pasqua deriva dalla parola ebraica Pesah che significa “passare oltre”.
Infatti, prima della venuta di Cristo, il popolo di Israele festeggiava uno degli episodi più importanti
raccontati nel Vecchio Testamento (la parte della Bibbia che accomuna sia ebrei sia cristiani).
Nonostante Dio avesse mandato nove piaghe che avevano devastato l’Egitto, il Faraone ancora si
ostinava a tenere in schiavitù gli ebrei; prima di mandare l’ultima piaga, la peggiore e la più
devastante, Dio avvisò il profeta Mosè affinché gli ebrei scampassero al massacro: avrebbero
dovuto macellare un agnello maschio, arrostirne la carne da mangiare con un pasto frugale e con il
sangue (simbolo di innocenza) marchiare tutti gli stipiti delle porte delle loro case.
L’alito divino, che soffiò la notte stessa, uccise tutti i primogeniti tranne quelli che vivevano nelle
case contrassegnate, tragedia che convinse il Faraone a lasciar andare il popolo ebraico: da qui la
Pasqua ebraica, che cade di sabato a differenza della Pasqua cristiana, il “passare oltre” come
fece Dio davanti alle porte segnate dal sangue dell’agnello, ed ecco anche perché il cibo
tradizionale di questo giorno è l’agnello.
Ma anche Gesù era ebreo e stava festeggiando proprio la Pesah quando venne tradito da Giuda
Iscariota, arrestato e mandato a morire sulla croce issata sul Monte Calvario, proprio perché i
sacerdoti del Sinedrio (massima autorità del popolo giudeo) accusarono Gesù di essersi
paragonato a Dio, reato punibile con la morte.
Il Prefetto romano Ponzio Pilato “se ne lavò le mani” (modo di dire ormai divenuto proverbiale) e fu
la folla a decidere che Gesù doveva essere crocifisso dopo aver percorso un lungo cammino
(cammino che fu poi chiamato “Passione”) di sofferenza, durante il quale, con addosso la grossa
croce di legno dove fu poi legato e inchiodato, fu deriso, umiliato e frustrato.
Così morì il Figlio di Dio il Venerdì Santo a 33 anni, tolto dalla croce e deposto in un sepolcro fuori
città.
Tre donne (Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salomè) la domenica si recarono al sepolcro
per terminare il rito di imbalsamazione ma scoprirono che la pietra che sigillava il sepolcro era
stata spostata e il corpo era sparito; fu l’apparizione di un Angelo che annunciò che Gesù, Figlio di
Dio, era risorto.
La domenica precedente la settimana di Pasqua, è chiamata la Domenica delle Palme, quando
Gesù arrivò a Gerusalemme, osannato da una folla di fedeli che posarono rami di palme sul suo
cammino, episodio che rese ancora più inviso Gesù sia alle autorità romane sia agli integralisti
religiosi.
La settimana che precede la Pasqua, chiamata la Settimana Santa, inizia con il Giovedì che
ricorda l’Ultima Cena, durante la quale Gesù annuncia il tradimento e la successiva sua uccisione
e avviene il rito della “Lavanda dei Piedi”, quando Gesù lavò in segno di umiltà i piedi ai suoi
Apostoli; il Venerdì è il giorno della Passione e della morte sulla Croce, in ricordo di ciò si celebra
la Via Crucis, con quattordici stazioni, in cui si rivive la sofferenza di Gesù; il Sabato è un giorno di
messe e lutto per la morte di Gesù; la Domenica, infine, è il giorno della Resurrezione e dei
festeggiamenti.
Per chiudere l’evento pasquale, nel dopoguerra in Italia fu aggiunta la festività della Pasquetta o
Lunedì dell’Angelo, per celebrare l’Angelo Cherubino che annunciò davanti al sepolcro la
Resurrezione di Dio.
I cristiani celebrano la Pasqua in diversi modi: per esempio, i protestanti preferiscono officiare le
funzioni all’Alba, i cattolici celebrano la Veglia pasquale, un’antica liturgia con rito battesimale, la
notte del Sabato Santo; gli ortodossi celebrano la Pasqua dopo 13 giorni, in base al calendario
giuliano.
Ma oltre l’agnello, simbolo sia cristiano sia ebraico, quali sono gli altri emblemi della nostra
Pasqua?
Iniziamo dalla Colomba: la leggenda dice che Alboino (530-572), Re dei Longobardi, durante
l’assedio di Pavia, che terminò poco prima del periodo pasquale, ricevette in dono dalla
popolazione del luogo un pane dolce a forma di colomba in segno di pace.
Secondo un altro racconto della tradizione lombarda, sembra che la nascita della colomba
pasquale sia dipesa da un monaco irlandese, San Colombano, fondatore di numerosi monasteri in
tutta Europa (in Italia quello di Bobbio, vicino a Piacenza), che invitato alla corte della Regina
Teodolinda durante la Quaresima, per non venire meno all’astensione dalle carni, accettò di
consumare il pasto dopo aver benedetto tutte le leccornie e le carni appetitose che erano state
preparate.
Quando il monaco impose le sue mani sui piatti, questi si trasformarono in bianche colombe di
pane…
In realtà, fu nel 1930 che Dino Villani, un pubblicitario che lavorava per una nota azienda dolciaria
milanese, pensò di risparmiare su un dolce tipico di Pasqua, “riciclando” l’impasto dei panettoni
natalizi e dando al dolce una forma simbolo pasquale come la colomba e rivestendo la superficie di
glassa all’amaretto e mandorle.
E le Uova di Cioccolato?
Sin dai tempi dei romani, si scambiavano uova vere, di gallina: durante la Settimana Santa non si
potevano mangiare uova, quindi tutte le uova che erano deposte in quei giorni venivano poi
colorate per distinguerle e regalarle ai bambini.
Nel Medioevo, in Germania e nei Paesi Scandinavi le uova erano pegno d’amore oppure premi per
giochi e palii, decorarle rosse è un’antica tradizione dell’Est Europa diffusasi poi in tutta Europa
come regalo di Pasqua.
Le uova decorate più famose e preziose sono quelle che lo Zar Alessandro III di Russia nel 1887
commissionò all’orafo Peter Carl Fabergé, smaltate e arricchite di pietre preziose e gioielli.
Sembra che le prime uova di cioccolato furono commissionate da Luigi XIV nel 1700, quando
chiese al suo cioccolatiere personale David Chaillou delle uova di cioccolato da regalare a Pasqua
al posto delle “solite” uova d’oro!
Le prime uova erano piene, ruvide e dure da mangiare ma poi piano piano si è passati ad una
raffinazione più evoluta e fu John Cadbury, fondatore di un’azienda di cioccolato con sede a
Birmingham in Inghilterra, che nell’800 inventò il primo uovo di cioccolato con la sorpresa dentro;
nel 1905 le uova vennero fatte anche con il cioccolato al latte.
Anche la moda è stata influenzata dalle celebrazioni pasquali: in America, con gli inizi della
commercializzazione della Pasqua negli anni ’70 e ’80 del 1800, le vetrine dei negozi cominciarono
a riflettere lo stile sempre più sfacciatamente decorativo degli altari del Paese.
Modiste e sarti riproducevano quei temi su vistosi abiti e cappellini da donna, creando una sorta di
“moda pasquale” che divenne presto molto popolare, tanto da dare vita a eventi annuali di “sfilate
di Pasqua” in cui l’élite della città sfoggiava in pubblico gli abiti più eleganti.
Per finire, vorrei ricordare alcune simpatiche tradizioni: in Francia si mettono a tacere dal Giovedì
Santo le campane perché “volano a Roma e tornano la Domenica” appena ricevuta la notizia della
Resurrezione, i bambini danno la caccia alle uova di Pasqua nascoste in casa e nel Sud Ovest
della Francia si prepara, come da usanza medievale, un’omelette gigante per consumare tutte le
uova che non sono state mangiate durante la Quaresima.
In Germania, la tradizione pagana si intreccia con i riti cristiani già dal nome Ostern, che deriva da
Eostre, una dea pagana della Primavera; le case si addobbano durante la Settimana Santa con
ramoscelli di ulivo, il Giovedì Santo si mangiano solo alimenti di colore verde per proteggere
l’organismo durante l’anno e il Venerdì e il Sabato Santo si usa fare grossi falò con i rami secchi
(altra usanza pagana per salutare l’arrivo della primavera), per arrivare al giorno di Pasqua quando
la tavola viene imbandita con uova di cioccolato, agnello e molti dolci. L’animale simbolo è il
coniglio pasquale (Osterhase), che è anche il simbolo della primavera, che viene nascosto nelle
uova (simbolo della nuova vita) per i più piccoli.
Usanza che sta prendendo piede anche da noi, è quella danese, dove si fanno addobbi che sono
dei veri e propri alberi di Pasqua, con i bambini che si dedicano alla caccia agli ovetti e gli adulti
che a tavola sorseggiano la Påskebryg, la birra speciale che viene prodotta solo a Pasqua.
Tutto ciò in ogni modo non toglie che la Pasqua sia vista dai cristiani come il compimento della
profezia biblica di un Messia che sarebbe risorto dai morti e avrebbe dato la vita eterna in cielo a
coloro che credono in lui.
Buona Pasqua!
Aprile 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.