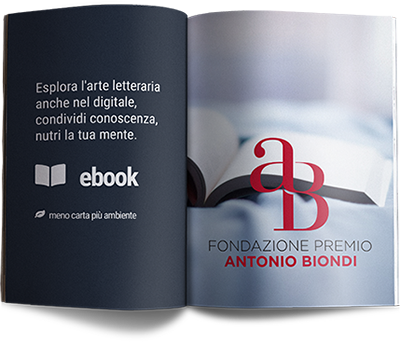EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Luigi Pirandello
A pochi giorni dall’anniversario della scomparsa…
«Io son figlio del Caos; e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco denominato, in forma dialettale, Càvusu dagli abitanti di Girgenti, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco “Kaos”»
Così scriveva Luigi Pirandello, nato ad Agrigento, la vecchia Girgenti (nome di origine araba fino al 1927), il 28 giugno del 1867 e scomparso a Roma il 10 dicembre 1936, uno dei più grandi scrittori, poeti e drammaturghi italiani.
È sempre stato uno dei miei autori preferiti, sin dai tempi del liceo; alla maturità, alla prova scritta di italiano uscì un tema su di lui e agli orali mi chiesero un argomento a piacere e quindi conclusi quanto già avevo iniziato con il mio tema.
L’estate, dopo gli esami, ebbi la fortuna di andare in Sicilia e finalmente potei visitare la casa di Pirandello: fresca degli esami, cominciai a parlare di tutto quanto vedevo nel museo e piano piano mi accorsi di avere un gruppetto di persone dietro che stava sentendo quanto io con eccitazione stavo dicendo…
E con mio sommo piacere, da poco ho saputo che Andrea Camilleri, l’altro mio grande autore preferito, siciliano anch’esso, nato proprio lì vicino, a Porto Empedocle, ancora giovane e sconosciuto nel 1947, insieme a quattro studenti, si diede da fare affinché venissero rispettate le ultime volontà testamentarie di Pirandello: anziché non si fossero potute spargere le sue ceneri, che almeno fossero seppellite nel suo giardino al Caos, cosa che, nonostante tante difficoltà specie da parte della chiesa, si rese possibile solo nel 1962.
Ma tornando agli inizi, Luigi Pirandello sarebbe dovuto nascere a Porto Empedocle, allora Borgata Molo, ma a causa di un’epidemia di colera la sua famiglia (con tradizioni risorgimentali, con il nonno materno esponente di spicco della rivoluzione siciliana del 1848-49, morto in esilio giovanissimo a Malta, e il padre Stefano che aveva partecipato alle imprese garibaldine), economicamente agiata per via del commercio ed estrazione dello zolfo, si era isolata in contrada “Cavusu”.
Pur avendo avuto un’infanzia serena, la sua difficoltà a relazionarsi con gli adulti ed in particolare con il padre lo spinse a migliorare il suo modo di esprimersi ed a studiare come si comportavano gli altri per essere il più possibile in sintonia con le persone.
Una domestica lo avvicinò alle pratiche religiose ma anche a tante credenze superstiziose, tra cui la presenza degli spiriti, e per tutta la vita si interessò al misticismo ed a credere infine ad una sua religione allontanandosi dalla Chiesa per colpa di un prete che aveva truccato, seppur in suo favore, un’estrazione a sorte.
Iscritto dal padre alla scuola tecnica, passò di nascosto agli studi classici per il suo interesse alla letteratura che a 11 anni gli fece scrivere la sua prima opera, Barbaro, di cui però non ne è rimasta traccia.
Frequentò prima l’Università di Palermo, poi si trasferì a Roma, dove iniziò a studiare Filologia Romanza che terminò però a Bonn (all’epoca un importante centro culturale) a causa di un conflitto con il rettore dell’Università di Roma.
Dopo la laurea, nel 1892 si trasferì di nuovo a Roma e conobbe Luigi Capuana, grazie al quale poté accedere ai vari salotti intellettuali, e rimase a vivere nella capitale anche dopo il matrimonio (1894) con Maria Antonietta Portulano con cui, nonostante fosse un matrimonio di interesse economico, ebbe un rapporto di amore e passione da cui nacquero 3 figli, Stefano (1895), Rosalia Caterina (Lietta-1897) e Fausto Calogero (1899).
Era il 1903 quando per via di un allagamento e di una frana nella miniera di zolfo di Aragona, di proprietà dei Pirandello, la famiglia fu ridotta sul lastrico, motivo per cui aumentarono i già presenti problemi psicologici della moglie, con attacchi schizo-paranoidi e atti di violenza per una forma morbosa di gelosia non solo nei confronti di tutte le donne che Luigi frequentava, ma anche nei confronti della figlia, che dopo un tentativo di suicidio se ne andò di casa.
Fu solo nel 1919 che Pirandello si convinse a ricoverare la moglie in una clinica di malattie mentali sulla Via Nomentana, a Roma, dove morì a 88 anni nel 1959.
Proprio per via della malattia della moglie Pirandello si interessò alla psicoanalisi di Freud, allo studio dei meccanismi della mente e a come la società si interfacciava con le malattie mentali.
Essendo in difficoltà economiche, oltre ad insegnare Stilistica al Magistero femminile, cominciò a dare ripetizioni private di italiano e di tedesco, ed a collaborare con il Corriere della Sera, dando spazio contemporaneamente alle sue opere letterarie, con il primo successo del romanzo Il fu Mattia Pascal, pubblicato nel 1904 e subito tradotto in diverse lingue, anche se all’inizio non fu bene accolto dalla critica che, a differenza del pubblico, non capì lo spirito innovativo del romanzo.
Ma il grande successo arrivò nel 1922, quando Pirandello capì che la sua vera arte era nel teatro grazie all’amico Nino Martoglio che gli chiese di rappresentare alcune sue opere nel 1910 al Teatro Minimo presso il Teatro Metastasio di Roma: Lumie di Sicilia e l’Epilogo (scritto nel 1892).
Non solo: sempre grazie a Martoglio, Angelo Musco, grande attore italiano di cinema e di teatro, volle portare in scena le opere pirandelliane, e la prima fu Lumie di Sicilia, che fu tradotta in siciliano e rappresentata con grande successo al Teatro Pacini di Catania il 1º luglio 1915.
La loro collaborazione ebbe fine per delle divergenze con la messa in scena di Liolà al Teatro Argentina di Roma. Poi ci fu la guerra che creò sia in famiglia sia nel suo lavoro non pochi disagi, con il già detto aggravamento della malattia della moglie e la prigionia in mano agli austriaci del figlio che rientrò ferito gravemente.
Nel 1925 fondò la Compagnia del Teatro d’Arte di Roma con i più grandi interpreti del teatro pirandelliano, Marta Abba (che fu poi legata a Pirandello tanto da essere considerata la sua musa) e Ruggero Ruggeri, compagnia che cominciò a viaggiare arrivando fino a Broadway e che nel giro di dieci anni rese Pirandello famoso tanto da essere considerato il più grande drammaturgo al mondo e da guadagnarsi il Premio Nobel per la Letteratura nel 1934 “per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale” (vorrei ricordare che nel 1935, in nome dei suoi ideali patriottici, partecipò alla raccolta dell’“oro per la patria” donando la medaglia ricevuta solo l’anno prima).
Molte sue opere furono riportate nel cinema e partecipò spesso alle riprese dei film, specie negli Stati Uniti, conoscendo molti famosi attori dell’epoca come Greta Garbo.
Dal punto di vista politico, nella sua vita condivise alcune delle idee dei giovani Fasci siciliani e del socialismo, ma l’unica idea forte che rappresentò Pirandello era che i siciliani avevano subìto le peggiori ingiustizie dai vari governi italiani.
Interventista nella I Guerra Mondiale (anche se avrebbe voluto evitare che il figlio si arruolasse), pochi anni dopo la fine della stessa guerra aderì al fascismo (per un certo conservatorismo che comunque aveva, guardava al Duce come riorganizzatore di una società in disfacimento e ormai completamente disordinata) e poi si iscrisse al PNF.
«Sono apolitico: mi sento soltanto uomo sulla terra. E, come tale, molto semplice e parco (…) potrei aggiungere casto...»
Pirandello, pur non ritrovandosi caratterialmente con Mussolini e molti gerarchi, non rinnegò mai la sua adesione al fascismo, motivata tra le altre cose da una profonda sfiducia nei regimi socialdemocratici, così come non si interessò mai del marxismo, perché vedeva la corruzione ovunque; inoltre, provava un deciso disprezzo per la classe politica del tempo che avrebbe voluto vedere cancellata dalla vita del Paese, e una forte sfiducia verso la “massa” caotica del popolo, che andava, secondo lui, istruita e guidata da una sorta di “monarca”.
Questa scelta di adesione al regime è stata spesso sia minimizzata sia accentuata dalla critica, poiché sostanzialmente l’ideologia fascista non ebbe mai parte nella vita e nell’opera pirandelliana, abbastanza al di fuori dalla realtà politica, tanto che egli non fu in grado di vedere e giudicare le violenze fasciste; tuttavia il contenuto idealmente anarchico, corrosivo, pessimista e quasi sempre anti-sistema delle sue opere era guardato con sospetto da molti intellettuali e uomini politici del PNF, che non lo consideravano degno di una vera “arte fascista”.
La critica fascista difatti non sempre esaltava le opere di Pirandello, spesso considerandole non conformi agli ideali fascisti: vi si vedeva una certa insistenza e considerazione di quella borghesia altolocata (che pure Pirandello non amava particolarmente) che il fascismo formalmente condannava come corrotta e decadente.
Anche dopo l’attribuzione del Nobel, parecchi suoi lavori furono accusati dalla stampa di regime di disfattismo, tanto che anche Pirandello finì tra i “controllati speciali” dell’OVRA (Opera Vigilanza Repressione Antifascismo).
Quasi in un esilio volontario dal clima culturale italiano, Pirandello viaggiò molto, in Francia e negli Stati Uniti.
Alla sua morte, le volontà testamentarie che negavano ogni funerale e celebrazione, misero in imbarazzo i fascisti e lo stesso Mussolini ordinò alla stampa che non ci fossero troppe celebrazioni sui quotidiani, ma che ne fosse data solo la notizia, come di un semplice fatto di cronaca.
Ci sarebbe ancora tanto da scrivere, ma vorrei fare un breve riassunto del suo pensiero tramite alcune delle sue opere (nell’uomo prevale sempre l’istinto animalesco e irrazionale), sull’umorismo (con il saggio in cui vengono raccolti commenti e annotazioni che definiscono la concezione di vita dell’autore e la poetica, dove il comico è l’“avvertimento del contrario”), sulla teoria della crisi dell’io (il solo modo per recuperare la propria identità è la follia, tema centrale di Enrico IV e di Il berretto a sonagli, dove addirittura ci viene data la ricetta per la pazzia, e a seguire l’evoluzione del personaggio che, abbandonando le convenzioni sociali e morali e vivendo secondo le proprie leggi, cala la maschera e diventa persona in Uno, nessuno e centomila).
Ricordando la “lanterninosofia”, con Il fu Mattia Pascal, arriviamo al contrasto tra vita e forma (“Se l’essenza della vita è il flusso continuo, il perenne divenire, quindi fissare il flusso equivale a non vivere, poiché è impossibile fissare la vita in un unico punto”: Maschere nude, la raccolta delle sue opere teatrali) da cui nasce il “relativismo psicologico” che si esprime in due sensi: orizzontale ̶ nel rapporto interpersonale ̶ e verticale ̶ nel rapporto che una persona ha con sé stessa.
Secondo le teorie della sua filosofia, riprendendo il suo romanzo Uno nessuno e centomila possiamo dire che ogni uomo è:
• Uno perché ogni persona crede di essere un individuo unico con caratteristiche particolari;
• Centomila perché l’uomo ha, dietro la maschera, tante personalità diverse quante sono le persone che ci giudicano;
• Nessuno perché, paradossalmente, se l’uomo ha centomila personalità diverse, è come se non ne possedesse nessuna, perché nel continuo cambiare non è capace di fermarsi nel suo vero io.
Il relativismo conoscitivo e psicologico su cui si basa il pensiero di Pirandello si scontra con il problema che ne deriva dell’incomunicabilità tra gli uomini (ogni uomo vede la propria realtà, quindi non ce n’è una oggettiva, ma tante quante sono le persone che credono di possederla) che sono quindi soli, esclusi dalla società e persino da sé stessi (Sei personaggi in cerca di autore, i cui protagonisti avvertono un sentimento di estraneità dalla vita ̶ forestieri della vita ̶ nonostante la continua ricerca di un senso dell’esistenza e di un’identificazione di un proprio ruolo che vada oltre la maschera o le innumerevoli maschere con cui si presentano in società o con le persone più vicine).
Si può reagire al relativismo?
Certo, con ironia, come in Pensaci Giacomino, ne Il giuoco delle parti… pensiamo a La patente, con il protagonista che accetta la maschera di iettatore che gli hanno dato ma almeno ne ricava un vantaggio.
Infine, un breve cenno al teatro; Pirandello divenne famoso proprio grazie a questo che chiama "teatro dello specchio", perché in esso viene raffigurata la vita vera, quella nuda, amara, senza la maschera dell’ipocrisia e delle convenienze sociali, di modo che lo spettatore si guardi come in uno specchio così come realmente è e diventi migliore.
Tante sono le sue opere teatrali, alcune delle quali rielaborazioni delle sue stesse novelle, che vengono divise in base alla fase di maturazione dell’autore:
• Prima fase ̶ Il teatro siciliano
- Luigi Pirandello è alle prime armi e ha ancora molto da imparare. Anch’essa come le altre presenta varie caratteristiche di rilievo; alcuni testi sono stati scritti interamente in lingua siciliana perché considerata dall’autore più viva dell’italiano e capace di esprimere maggiore aderenza alla realtà (Lumie di Sicilia, Pensaci, Giacomino!, Liolà).
• Seconda fase ̶ Il teatro umoristico/grottesco
- Mano a mano che l’autore si distacca da verismo e naturalismo e si avvicina al decadentismo, si ha l’inizio della seconda fase con il teatro umoristico. Pirandello presenta personaggi che incrinano le certezze del mondo borghese: introducendo la versione relativistica della realtà, rovesciando i modelli consueti di comportamento, intende esprimere la dimensione autentica della vita al di là della maschera (Così è - se vi pare, Il berretto a sonagli, La patente, Ma non è una cosa seria, Il giuoco delle parti…).
• Terza fase ̶ Il teatro nel teatro
- Nella fase del teatro nel teatro (metateatro) le cose cambiano radicalmente, per Pirandello il teatro deve parlare anche agli occhi, non solo alle orecchie, ripristinando una tecnica teatrale shakespeariana, il “palcoscenico multiplo”, in cui vi può per esempio essere una casa divisa in cui si vedono varie scene fatte in varie stanze contemporaneamente; inoltre, il teatro nel teatro fa sì che si assista al mondo che si trasforma sul palcoscenico. Pirandello abolisce anche il concetto della quarta parete, cioè la parete trasparente che sta tra attori e pubblico: in questa fase, infatti, Pirandello tende a coinvolgere il pubblico che non è più passivo ma che rispecchia la propria vita in quella degli attori in scena (Sei personaggi in cerca di autore, Enrico IV, Vestire gli ignudi, L’uomo con il fiore in bocca, Questa sera si recita a soggetto, Non si sa come…).
• Quarta fase ̶ Il teatro dei miti
- A questa fase fanno parte solo tre opere (Trilogia dei miti): La nuova colonia, Lazzaro, I giganti della montagna (opera incompiuta).
Riassumere la storia di un grande autore è sempre molto difficile, ma tracciarne la vita e le opere è sicuramente un modo per incuriosire e rimandare ad una lettura più approfondita.
Vorrei segnalare su You Tube una simpatica rubrica chiamata BIGnomi (ricordiamo tutti il famoso Bignami, estrema soluzione in prossimità degli esami…) di un comico italiano Angelo Pintus: in tre minuti cita argomenti e autori, tra cui Luigi Pirandello, in maniera semplice ed efficace…
Dicembre 2023 © Maria Teresa Protto

Direttore responsabile Luigi Canali

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.