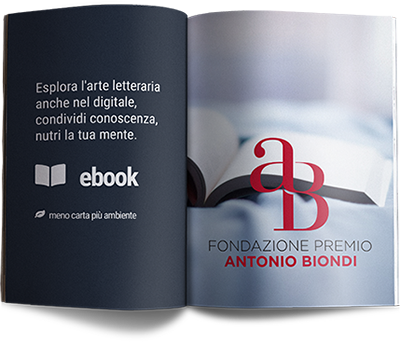EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
La Garbatella
Il “Barocchetto” di Roma
Per molti è un quartiere “giovane”, abituati come siamo a vedere Roma con le sue antichità e la sua
storia millenaria, per altri è uno dei quartieri come Testaccio rimasti il simbolo della romanità, per altri
ancora è un quartiere così particolare, avvolto nel silenzio e nella tranquillità pur stando a pochi
chilometri dal Colosseo e dal centro di Roma.
Per risalire alle origini del quartiere della Garbatella non si deve andare molto lontano.
Dopo la Prima guerra mondiale a Roma ci fu un grande sviluppo edilizio, come del resto avvenne
anche nel secondo dopoguerra.
Il quartiere dove venne costruita la Garbatella, nel Medioevo ha avuto vari proprietari sia laici sia
ecclesiastici, tra tutti il più importante fu il Monastero di Sant’Alessio all’Aventino, che sin dal XII
secolo aveva beni nelle contrade della Bagnaia (nome dato dai bagni fatti costruire da Papa Simmaco
verso l’anno 500).
Sicuramente, agli inizi del XX secolo, quando si iniziò all’esproprio per costruire il quartiere, su un
territorio di circa 26 ettari, la maggior parte delle proprietà erano della famiglia Torlonia e degli eredi di
Mariano Armellini (archeologo e storico del 1800).
Ancora oggi, a Piazza Benedetto Brin, sui Colli di San Paolo che dominano la Basilica di San Paolo
fuori le Mura, possiamo vedere la targa murata sulla facciata dell’edificio centrale della piazza che
ricorda Re Vittorio Emanuele (il famoso Re Pippetto) quando pose il 18 febbraio 1920 la prima pietra
del nuovo quartiere: “Per la mano augusta di S.M. il Re Vittorio Emanuele III l’Ente autonomo per lo
sviluppo marittimo e industriale e l’Istituto delle case popolari di Roma con la collaborazione delle
cooperative di lavoro ad offrire quieta e sana stanza agli artefici del rinascimento economico della
capitale questo aprico quartiere fondano oggi XVIII Febbraio MCMXX”.
L’allora sindaco Adolfo Apolloni aveva a cuore l’edilizia popolare che vedeva un quartiere incluso nel
verde.
Paolo Orlando, urbanista a capo dei lavori, nei progetti aveva interesse ad unire Roma con il Lido di
Ostia tramite un canale parallelo al Tevere che però non venne mai costruito, progetto che avrebbe
creato un porto commerciale molto più vicino al centro della città, a ridosso del confine tra la
Garbatella e Testaccio, dove ora sorge Via del Porto Fluviale, con annesse costruzioni che avrebbero
ospitato i futuri lavoratori portuali.
Anche i nomi delle strade e delle piazze dovevano essere intitolati a persone e soggetti che facevano
riferimento al mondo navale.
Quando iniziarono i lavori, l’area era quasi del tutto disabitata e coperta da vigne e pascoli per pecore,
e da qui partiva la Via delle Sette Chiese che univa la Via Appia con la Via Ardeatina, strada che veniva
usata dai pellegrini diretti alla Basilica di San Sebastiano e che ancora oggi viene usata per il
pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore sulla Via Ardeatina.
Qui inoltre sorge la Chiesa dedicata ai Santi Isidoro (agricoltore) ed Eurosia (Vergine e Martire), nota
come Chiesoletta, unita attraverso l’oratorio alla Chiesa di San Filippo Neri in Eurosia (costruita nel
1952 e dal 1967 eletta parrocchia) e dove, secondo una leggenda, si sarebbero incontrati Filippo Neri,
che aveva ideato il pellegrinaggio delle Sette Chiese, e Carlo Borromeo nel XVI secolo.
Ma non è questo il solo luogo religioso: poco più avanti, prima di Largo delle Sette Chiese, sorge un
convento delle Suore Clarisse Cappuccine.
Di sicuro, nel quartiere vennero trasferite tutte le famiglie sfollate che abitavano ai Borghi (la famosa
zona chiamata Spina di Borgo) con le case che furono abbattute per realizzare Via della Conciliazione,
oltre agli abitanti delle case sfollate per fare Via dei Fori Imperiali, oppure dalle baracche di Ponte
Milvio, Porta Latina e Ponte Lungo, gente, in ogni caso, che viveva da generazioni a Roma.
Anche sul nome da dare al nuovo quartiere ci furono delle difficoltà: fu ipotizzato Concordia, per
richiamare la speranza di una pace sociale in tempi di disordini, oppure Remuria, nome che Romolo
avrebbe dato alla sua città fondata su questo colle e non sul Palatino, come invece afferma Tito Livio
nella sua opera Ab Urbe condita - libri CXLII.
Alla fine, fu deciso Garbatella: ma perché?
Sembra ci fosse un’osteria situata su uno sperone roccioso di Via Ostiense, sovrastante la Basilica di
San Paolo all’altezza del Sepolcreto Ostiense, dove oggi ha inizio Via degli Argonauti, e davanti a cui
passavano i pellegrini che percorrevano Via delle Sette Chiese.
Questa via si chiamava così perché era il percorso incluso nel pellegrinaggio, di cui già accennato, per
visitare le sette chiese di Roma, cioè San Pietro, San Paolo fuori le Mura, San Giovanni e Santa Maria
Maggiore, che sono le 4 basiliche, più le altre 3 chiese più famose di Roma: San Sebastiano alle
catacombe di Via Appia Antica, Santa Croce in Gerusalemme e San Lorenzo al Cimitero del Verano.
A tal proposito, a Roma c’è un detto proverbiale in uso già dal Medioevo: “Fare il giro delle Sette Chiese
di Roma” che, prendendo spunto dal pellegrinaggio che in particolare in occasione del Giubileo
serviva a farsi perdonare i peccati commessi, vuol dire fare qualcosa di complicato e che richiede
molto tempo.
Tornando all’osteria, la proprietaria di nome Carlotta (o Maria, secondo altri), sarebbe stata tanto
benvoluta dai viaggiatori che chiedevano ostello presso la sua locanda, da meritare il nome di
"Garbata Ostella", successivamente sincopato in “Garbatella”.
Molti maliziosi non intendevano attribuirle solo le sue caritatevoli attitudini verso i bisognosi,
pensando ad altre attenzioni che riservava a certi clienti.
Una seconda ipotesi sul nome “Garbatella” potrebbe invece derivare dall’amenità del luogo, pur
essendo periferico e poco raccomandabile; un’ultima interpretazione, con qualche fondamento
scientifico, fa riferimento al tipo di coltivazione della vite detto “a barbata” o “a garbata”, nella quale le
viti vengono appoggiate ad alberi di acero od olmo, in uso nei terreni detti “Tenuta dei 12 cancelli”
(comprendenti l’attuale Via delle Sette Chiese), posseduti nel XIX secolo da monsignor Alessandro
Nicolai, ministro dell’Agricoltura di Papa Gregorio XVI.
Ma sul volume Garbatella 100, il racconto di un secolo, edito per i tipi di Iacobelli – novembre 2019 ̶
abbiamo un’ultima ipotesi: lo studioso Giorgio Guidoni rivela che Garbatella era l’appellativo di
Clementina Eusebi, l’ostessa che nel periodo 1835-1850 gestì questa famosa osteria, e la mamma di
Clementina si chiamava Maddalena Garbata, vedova Eusebi.
Forse, per distinguere le due donne, la madre era chiamata Garbata e la figlia Garbatella…
Pure se fa parte del quartiere Ostiense, la parte più antica della Garbatella, che ricalca lo stile
architettonico degli anni Venti e Trenta, è chiamato di per sé “quartiere” o “rione”.
La Garbatella è tradizionalmente suddivisa in lotti, occupati da costruzioni che circondano cortili e
giardini, i quali, soprattutto in passato, erano punti di ritrovo per la popolazione, con lavatoi e stenditoi,
botteghe e cantine, sedie e muretti.
L’assetto architettonico della zona è un compromesso tra l’estetica e la pratica: le abitazioni sono
collocate, almeno nel nucleo storico, in villini o palazzine di tre piani al massimo, con grande cura per i
dettagli e per la diversificazione degli stili: casette basse con cortili, orti, vie tortuose, strette, molte
delle quali oggi sono pedonali.
Il rosso è il colore predominante delle facciate, dei mattoni a vista in contrasto con il bianco degli
stucchi che abbelliscono molti edifici.
L’architettura della Garbatella fu inizialmente improntata al modello inglese delle città giardino, ben
collegate e vicine alla città, abitate da operai e che comprendevano ampi spazi verdi coltivabili, così
da fornire ai lavoratori residenti una preziosa, e ulteriore, fonte di sussistenza: l’orto.
Nei lotti più antichi ancora rimasti (dai 66 iniziali ne sono rimasti meno della metà, alcuni furono
demoliti negli anni Settanta, da parte di speculatori edilizi) nei pressi di Piazza Benedetto Brin si nota
quella che era la struttura che era stata ideata per il quartiere: il rapporto tra case e verde doveva
conferire un aspetto agreste, come se fosse un piccolo borgo, per evitare che i futuri abitanti, specie
quelli provenienti dalle campagne laziali, subissero un trauma nel venire a vivere in città, potendo così
ricostruire una rete di rapporti sociali che con l’ampliamento costante della città si andava sempre più
perdendo.
Furono gli stessi creatori dei primi lotti a chiamare lo stile della Garbatella Barocchetto: ci sono le
modanature di tipo medievale, le figure di animali nei fregi, le decorazioni floreali o di origine botanica,
ma, essendo costruzioni popolari e quindi povere, non venivano usati marmi pregiati ma piuttosto
stucco e calce bianca.
Con l’avvento del fascismo, il quartiere cambiò: fu imposto all’ICP (Istituto delle Case Popolari) di
ristrutturare il centro di Roma in stile impero, il rapporto verde-edificato calò sensibilmente, l’idea del
porto fluviale venne definitivamente abbandonata e cominciarono ad essere costruite abitazioni più
simili ai moderni condomini che alle precedenti villette.
Restò comunque ferma l’intenzione di costruire, oltre agli spazi abitativi privati, se non giardini e orti
comuni, comunque spazi pubblici, come stenditoi o asili nido.
Si cominciò allora a costruire palazzi più grandi e alti per ospitare un sempre crescente numero di
immigrati, come ad esempio il Lotto VIII in via Luigi Fincati.
Il culmine di questo mutamento si nota nell’impianto progettuale dei tre lotti chiamati Alberghi Rossi
o Suburbani (Rosso, Bianco e Giallo) nei pressi di Piazza Eugenio Biffi, strutture nate pochi anni dopo
le villette dell’inizio dell’edificazione dell’area (dal 1927), ma significativamente differenti dal punto di
vista funzionale ed estetico: dovevano ospitare “temporaneamente” gli sfollati ed avevano molti spazi
comuni come i bagni, le cucine e le lavanderie.
L’Albergo Rosso si riconosce per via della Torretta dell’Orologio posto in cima che si fermò alle ore
11:25 quando ci fu il bombardamento del 7 marzo 1944.
Per festeggiare i cento anni dalla nascita della Garbatella, l’orologio è tornato a funzionare.
L’Albergo Bianco ospitava la Maternità delle suore Figlie della Carità, e sono tanti i bambini del
quartiere nati in questa struttura, talmente famosa che addirittura a dicembre del 1931 Mahatma
Gandhi venne a visitare gli alberghi suburbani, e rimase talmente soddisfatto del nido dove c’era la
Maternità dell’OMNI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) che lo prese come esempio.
Da segnalare i tredici villini del Lotto 24, denominati anche "casette modello", tra via delle Sette
Chiese, via De Jacobis e via Borri, destinate al ceto medio e apprezzate anche da architetti stranieri
dell’epoca.
Il lotto fu edificato in occasione del XII Congresso Internazionale delle Abitazioni e dei Piani Regolatori
del 1929 ed è considerato tra i più belli e interessanti: agli ingressi sono state apposti dei marmi con
iscritti i nomi degli architetti che idearono e costruirono le varie palazzine; vinse il concorso l’edificio
ad angolo tra Via delle Sette Chiese e Via Cristoforo Borri, progettato dall’architetto Mario De Renzi,
chiamata la piccola casa bifamiliare, punto di riferimento per afferrare la vitalità della cultura romana
sul finire degli anni Venti.
Importante da considerare è che nonostante l’urbanistica fascista abbia cambiato notevolmente la
primaria idea della città giardino, la Garbatella fu conservata come borgata a misura d’uomo, molto
diversa dalla Baraccopoli di Shangai, ovvero l’odierna Tor Marancia, oppure Acilia, dove vennero
trasferiti sfollati meno fortunati.
Ma Garbatella oltre a giardini e lotti ha altre particolarità, a cominciare dal Pincetto, un terrazzino che
porta verso il fiume, visto che queste dovevano essere le abitazioni di chi avrebbe dovuto lavorare per
il porto in fase di costruzione; ora la scalinata porta alla Terza Università di Roma, la fontana di pietra
scoperta più di cento anni fa dal fondatore dei magazzini municipali da cui zampilla l’acqua ci sta
ancora ma manca il chiacchiericcio di chi la sera, all’imbrunire, dopo il lavoro si fermava sulla piazza a
raccontarsi la giornata in attesa della cena…
Nel giardino pubblico (ex vigna Serafini) si trova l’ingresso delle Catacombe di Commodilla, la
fondatrice o donatrice del terreno su cui sorse una piccola basilica ipogea (IV secolo) e un complesso
cimiteriale dipinto con scene bibliche (con un’effige del Cristo orientale), conosciuto anche col nome
dei due principali martiri ivi sepolti, Felice e Adautto.
Sempre in tempi poco lontani, sono state messe due targhe ricordo in marmo travertino: al lotto 28 in
via Guglielmo Massaia 22, c’è la targa dedicata a Iole Zedde, una sedicenne morta il 12 settembre
1944 a causa di una sventagliata di mitra di un giovano soldato tedesco di guardia ai vagoni della
Stazione Ferroviaria Ostiense, la seconda targa ricorda Alvaro Amici, un cantante della canzone
romana, nato e vissuto al lotto 31 vicino alla Fontana della Carlotta.
E visto che da sempre Roma è considerata una città romantica, perfetta per una fuga d’amore o
qualche giorno di riposo di coppia, come non fare una passeggiata per il Vialetto degli Innamorati?
Si parte sempre dal Pincetto, e dopo aver passato l’arco con l’edicola di una Madonnina e i due
“Gargoyle” ai lati delle prime costruzioni, attraverso viuzze e viali con scorci antichi e alberi maestosi
si arriva alla scalinata degli innamorati, la cui leggenda dice che salendovi insieme si riuscirà ad
affrontare tutte le avversità.
Gli innamorati che percorrono queste vie passano il ponticello medievale in Piazza Eugenio Biffi e poi
si soffermano a bere alla Fontana della Carlotta, in Piazza Ricoldo da Montecroce: anche qui si dice
che bevendo da questa fontana gli innamorati vivranno insieme tutta la vita e il loro amore non si
esaurirà mai.
Da vedere a Piazza Bartolomeo Romano, il Teatro Palladium, oggi di proprietà dell’Università di Roma
Tre, e l’Edificio dei Bagni Pubblici, progettato per accogliere i primi servizi di pertinenza al quartiere.
In questa zona ci sono molti murales, oltre a quello più famoso della bella Ostessa: a Via Basilio
Brollo ci stava una scritta di valore storico erroneamente cancellata nel 2019 da un addetto del decoro
urbano: la scritta diceva «Vota Garibaldi Lista N°1» ed era un manifesto elettorale delle elezioni
politiche del 1948, le prime dopo la fine della Seconda guerra mondiale, le prime della storia della
Repubblica e in cui votarono anche le donne. Il volto di Giuseppe Garibaldi era il simbolo del Fronte
Democratico Popolare, la lista che teneva insieme il Partito Comunista Italiano (PCI) di Palmiro
Togliatti e il Partito Socialista Italiano (PSI) di Pietro Nenni.
Altro murales è quello dedicato al bambino Alfredino Rampi che nel 1981 cadde in un pozzo a
Vermicino: la diretta televisiva tenne con il fiato sospeso per ore e ore tutta l’Italia sperando nella
salvezza del bambino di soli 6 anni che purtroppo non ce la fece.
In un altro lotto ci sta il murales di Alberto Sordi, uno dei più grandi attori italiani, ritratto mentre si sta
prendendo un caffè al vetro, cosa che a Roma è abbastanza richiesto: l’attore era legato alla
Garbatella perché ci abitavano le sorelle.
Oltre alla già citata targa, ci sta anche un murales su Alvaro Amici, il cantante.
Come tutti i quartieri degni di nota, la Garbatella è stata il set di molti film, a partire da Alberto Sordi
che nella Chiesoletta girò una scena del film Mamma mia che impressione.
A seguire, nel 1993 Nanni Moretti con Caro Diario, a bordo di una Vespa mostrò le strade del quartiere
e i lotti.
Ma più di tutti ci fu una serie televisiva dal 2006 al 2014, che ebbe talmente tanto successo da arrivare
a sei stagioni: i Cesaroni, ancora oggi con la famosa Bottiglieria, che in realtà è un bar, divenuta
famosa in tutta Italia e che ha contribuito, più di tante altre cose, a far conoscere questo bellissimo, e
unico, quartiere.
__
Nella foto murales dedicato al bambino Alfredino Rampi che nel 1981 cadde in un pozzo a Vermicino
Giugno 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.