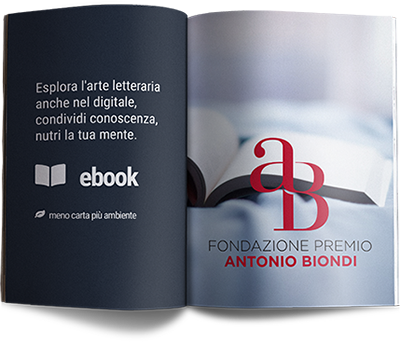EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
In giro per Rioni
Il Cacco e le “quadrature”
Siamo nella zona più antica di Roma, tra i Rioni Campo Marzio e Pigna.
Campus Martius nel Medioevo era la zona più popolata di Roma; nel vedere lo stemma che è una
mezzaluna, viene da pensare che forse la sua forma “ad anfiteatro” è perché durante l’età imperiale
qui ci stavano anfiteatri, teatri e stadi.
Rione Pigna deve invece il suo nome ad una scultura enorme, ancora oggi visibile in Vaticano, che fu
rinvenuta durante degli scavi.
Arriviamo a Via Santo Stefano del Cacco e qui, inglobata tra i palazzi, tanto da sembrare molto
piccola, troviamo la Chiesa di Santo Stefano del Cacco; solitamente aperta la domenica mattina,
merita una visita perché all’interno in realtà è una Chiesa molto grande e molto antica.
La particolarità del nome si deve ad una statua che venne rinvenuta nel luogo in cui un tempo si
trovava il Tempio di Iside (o Iseo Campense, in latino Iseum Campense), un santuario, dedicato alla
divinità egizia Iside e al suo sposo Serapide, che sopravvisse fino al V secolo.
Il culto di Iside fu introdotto a Roma nel I secolo avanti Cristo, anche se l’aristocrazia tradizionalista ne
fu contraria: nel 53 a.C. il Senato decise di demolire i sacelli (recinti sacri) privati costruiti dentro le
mura, nel 43 a.C. fu costruito l’Iseo, ma prima Agrippa (nel 23 a.C.) e poi Tiberio sospesero il culto, che
fu poi reintrodotto da Caligola per durare fino alla fine dell’Impero.
Il tempio fu distrutto da un incendio nell’80 e ricostruito da Domiziano, con successive modifiche
attuate da Adriano, ma la maggior parte delle strutture furono restaurate in età severiana.
Il santuario era lungo 240 metri e largo 60, articolato in tre parti: al centro c’era un’area rettangolare,
alla quale si accedeva tramite archi monumentali, a seguire una piazza scoperta ornata da coppie di
obelischi in granito rosso o rosa di Siene (oggi Assuan, città a sud dell’Egitto) – tanti furono ritrovati nei
pressi della Basilica di Santa Maria sopra Minerva – e sfingi; al centro di questo slargo sorgeva il
tempio di Iside.
Un’esedra semicircolare con abside ospitava presumibilmente il serapeo, sul quale oggi sorge la
Chiesa di Santo Stefano del Cacco.
Tra gli obelischi facenti parte del tempio, oggi vediamo quello del Pantheon, della Minerva e quello di
Dogali (vicino alle Terme di Diocleziano) e il suo gemello nel giardino di Boboli a Firenze.
Andato nel tempo in rovina, man mano che si scavava nei secoli successivi venivano ritrovati oggetti
che, come gli obelischi, spesso furono utilizzati per ornare Roma, specie nel periodo rinascimentale.
Qui fu trovata una statua rappresentante un babbuino, di una specie che veniva chiamato Macaco, in
romanesco “Cacco”, che in realtà era la statua del Dio Thot, che nella mitologia egizia era il Dio della
scrittura, della magia, della sapienza, della matematica e geometria, inventore soprattutto dei
geroglifici; patrono degli scribi, è grazie a lui che l’uomo ha imparato a scrivere.
Il Cinocefalo egiziano (dal greco antico κυνοκἐφαλος , “testa di cane”, essere mitico dal corpo d’uomo
e dalla testa di canide con cui era raffigurato il Dio egizio Anubis) in cui i romani videro il Cacco, era
dinanzi alla porta della Chiesa, ed ecco il nome sia della Via sia della Chiesa, che in origine era stata
chiamata anche Santo Stefano della Pigna, la stessa Pigna di epoca romana che come si diceva
all’inizio, ha dato il nome al quartiere ed è tuttora visibile al Vaticano.
Tornando alla Chiesa, sembra che fu edificata da Papa Pasquale I nel IX secolo, e l’immagine del Papa
era raffigurata nel mosaico absidale che fu distrutto nel 1607.
Risale invece al XII secolo il campanile, ora inglobato nel monastero accanto, e l’abside.
Papa Pio IV diede la Chiesa ai Padri Silvestrini nel 1563 in cambio di provvedere alla “cura delle anime”
nonché ai vari restauri nel corso degli anni successivi.
Come anticipato, la Chiesa al suo interno ha tre navate molto ampie, del tipo basilicale, e tra le opere
in essa contenute c’è un affresco di Perin del Vaga (Cristo in pietà) e nell’abside un’opera di Cristoforo
Casolani (il Martirio di Santo Stefano).
Proseguendo su Via di Santo Stefano del Cacco, sulla sinistra alla fine della strada sorge un piede di
marmo molto grande posto su un basamento; originariamente, nel Cinquecento la scultura era
addossata in un palazzo collocato in Via Piè di Marmo (la Via dove va a confluire proprio Via Santo
Stefano del Cacco) ma fu spostata dove attualmente è collocata nel 1878 affinché non ostacolasse il
passaggio del corteo funebre di Vittorio Emanuele II diretto al Pantheon.
Questo piede sinistro è lungo circa un metro, con un sandalo con suola rialzata e lacci in cuoio da
legarsi intorno al collo del piede, calzatura tipica delle sacerdotesse isiache oppure poteva essere
stato calzato da un acrolito Campense, ma sempre risalente al Tempio di Iside e Serapide.
Alcune teorie dicono che era parte di un’unica, grande statua il cui frammento più grande potrebbe
essere Madama Lucrezia, il busto di Iside Sothis collocato davanti alla Basilica di San Marco a Piazza
Venezia.
Ma c’è anche un’altra interpretazione: su Via Santo Stefano del Cacco c’era un calzolaio e così la
statua sarebbe stata una vera e propria insegna pubblicitaria!
Da Via Piè di Marmo, poco più avanti a sinistra si arriva a Via di Sant’Ignazio dove troveremo la Chiesa
di Sant’Ignazio di Loyola, Chiesa in stile barocco, costruita nel 1626 sull’antica Chiesa dell’Annunziata
che era la cappella del Collegio Romano situato a fianco della Chiesa, Chiesa divenuta troppo piccola
per accogliere tutti gli studenti che lì vi arrivavano.
Fu dedicata a Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, un ordine che venne
riconosciuto nel 1540 da Papa Paolo III con la bolla Regimini militantis ecclesiae, e che venne
canonizzato nel marzo del 1622.
La Compagnia di Gesù era un movimento complesso fortemente caratterizzato spiritualmente e con
un programma culturale che partiva da una intensa attività educativa, movimento che fu responsabile
dello sviluppo dell’arte che avvenne in Europa tra il VXII e il VXIII secolo.
Anche su questa Chiesa sembra ci sia un mistero…
Partiamo da quando il vescovo Ludovico Ludovisi (morto nel 1632), nipote di papa Gregorio XV,
divenne mecenate della Chiesa in quanto devoto alla Compagnia di Gesù, sin dai tempi della scuola.
Aveva versato una forte somma (100 mila scudi) per far sì che “l’edificio fosse ampio e bello come
pochi altri istituti”, ma essendo vicino al noviziato di Sant’Andrea, il papa disse subito che un edificio
troppo alto gli avrebbe impedito la vista del Quirinale, e quindi il cardinale spostò il luogo vicino al
Collegio Romano, l’istituto dove andavano a studiare i Gesuiti al centro di Roma.
Furono poi gli stessi Gesuiti a creare problemi al cardinale: essendo cambiate le condizioni rispetto a
quando avevano dovuto accettare le disposizioni del cardinale Farnese, lo stesso cardinale Ludovisi
chiariva che la sua ammirazione per i Gesuiti era dovuta almeno in parte alla «... potenza et autorità
c’hanno quasi con tutti i Prencepi».
Non si capisce bene quale fosse la sua attività viste le allusioni degli autori contemporanei, dovendosi
misurarsi con questo “potere”, ma tutti concordano nel dire che il cardinale Ludovisi bandì un
concorso per la nomina dell’architetto per la costruzione dell’edificio e che tra coloro che
presentarono dei disegni ci fu anche il Domenichino (Domenico Zampieri), suo particolare protetto.
Ci fu un grande amico del Domenichino che, restio a parlare del concorso, disse che sì, vi partecipò,
ma «Iddio sa qual fine sortì, e di questo è superfluo il parlarne».
Un altro storico, Giovan Pietro Bellori, racconta che il Dominichino eseguì parecchi disegni per
Ludovisi, ma poi ricevette la visita dei Gesuiti che gli dissero che non si “affaticasse, perché volevano
seguitare la forma della loro Chiesa del Gesù, come la prima, e la più bella, che era servita di esempio,
e di modello, alle altre chiese”; l’artista rispose che si sarebbero potuti accontentare di avere due
modelli, e che egli avrebbe proposto il secondo, ma tutto fu vano.
Quando alla fine l’incarico fu dato al padre gesuita Orazio Grassi (architetto, matematico e
astronomo), famoso per essere stato avversario di Galileo Galilei, si dice che Domenichino si ritirò con
rabbia quando si accorse che il Grassi aveva unito insieme i due disegni che egli aveva presentato e
che erano stati decisamente censurati dai Gesuiti.
Da parte gesuita, non si parla di Domenichino ma che fu il cardinale Ludovisi a scegliere tra tutte le
proposte quelle del Grassi, a cui subentrò successivamente un altro gesuita, il Sasso.
Di sicuro, le pressioni devono essere state molto forti.
Ludovisi continuò a seguire i lavori della costruzione, anche con la richiesta di una commissione di
architetti per verificare meglio i progetti di Grassi, ma in realtà non esercitò più alcun controllo, se non
come finanziatore, tanto che, prima di morire, fece un ulteriore lascito alla Compagnia di Gesù.
Tornando al nuovo edificio, visto che doveva servire agli studenti del Collegio Romano e non al
pubblico culto, per la decorazione delle cappelle laterali furono gli stessi Gesuiti ad assumersene il
compito, facendo quindi economia ricorrendo ad un loro stesso membro: Pierre de Lattre, di St. Omer,
entrato nel noviziato di Sant’Andrea nel 1626.
Fu lui ad eseguire tutti i dipinti che a quell’epoca si potevano vedere nella Chiesa e in sacrestia.
Affrescò la volta della sacrestia, completò sei dipinti per le cappelle laterali ed eseguì in pittura un
finto altare sulla parete interna dell’abside.
Ben poco è rimasto delle sue opere, essendo in realtà un artista del tutto insignificante.
Nel 1640, il tempio risultava ancora incompiuto.
Una volta ancora i Gesuiti si vedevano superare dai loro rivali, gli Oratoriani, che facevano eseguire
due opere assai importanti per i successivi sviluppi dell’arte barocca, un affresco di Pietro da
Cortona sul soffitto della sacrestia della loro Chiesa ed un edificio del Borromini destinato alla
funzione di biblioteca e di sala da concerti per le esecuzioni di musica religiosa per cui erano tanto
famosi.
La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola ha una facciata con capitelli corinzi e una grande finestra da cui
entra la luce che illumina la navata e, sempre nella parte superiore si notano due volute riverse molto
simili a quelle della basilica di Santa Maria Novella a Firenze di Leon Battista Alberti.
All’interno, la Chiesa, lunga 81,5 metri e larga 43 metri, ha la forma di croce latina, con presbiterio
absidato e sei cappelle laterali, tre a sinistra e tre a destra.
Ma ciò che rende questa Chiesa unica, sono le due quadrature (oppure “sott’in su”, genere pittorico
illusionistico del Rinascimento, del Barocco e del Rococò, con la quale la prospettiva ed altri effetti
spaziali vengono impiegati per creare l’illusione di uno spazio tridimensionale dal punto di vista dello
spettatore, su una superficie piatta, semicurva o curva) di Andrea Pozzo.
Nella navata, a terra, ci sta un disco dorato, da cui, osservando in alto, si può ammirare la
simulazione prospettica di un secondo tempio, sovrapposto al primo, quello reale della Chiesa:
dipinto tra il 1691 ed il 1694, Andrea Pozzo realizza, in pratica un secondo edificio sacro (illusorio) che
sormonta quello in cui ci si trova.
In poche parole, grazie ad una incredibile padronanza della prospettiva ed all’inserimento di elementi
architettonici dipinti (archi, colonne, trabeazioni), Andrea Pozzo costruisce una seconda Chiesa che
si innalza illusoriamente sopra la prima.
Bisogna poi sapere che il soffitto sul quale l’artista ha realizzato l’affresco è piatto.
Un po’ più avanti verso l’altare, c’è un altro punto di osservazione della seconda tela prospettica, di
13 metri di diametro, sopra la crociera: è la riproduzione di una cupola, dipinta (da Andrea Pozzo nel
1685, ma riprodotta sulla base dei disegni e degli studi originari nel 1823 da Francesco Manno,
essendo andato distrutto da un incendio l’originale), per riprodurre quella in muratura che, forse per
motivi economici oppure per opposizione degli abitanti del luogo che non desideravano una cupola
troppo grande che oscurasse loro il sole, non venne mai realizzata.
Maggio 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.