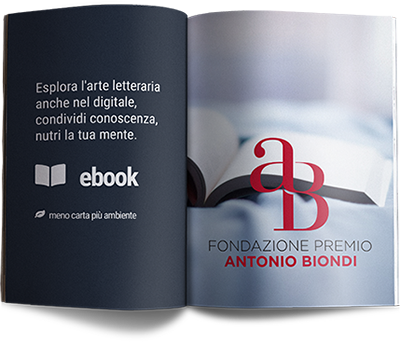EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
Il Signor G
«Una brutta giornata / chiuso in casa a pensare / una vita sprecata non c’è niente da fare / non c’è via di scampo mah, quasi quasi mi faccio uno shampoo»
Era il 1° gennaio 2003 quando la musica italiana perse uno dei suoi più grandi artisti, Giorgio Gaber, cantautore, drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano.
Parlare di quarant’anni di vita artistica non è certamente facile, ma mi piace cercare di riassumere almeno le tappe principali di questa carriera straordinaria che tra alti e bassi ha condizionato il panorama musicale (e non solo) italiano nei periodi sicuramente più significativi che vanno dagli anni ‘60 agli anni 2000, anche se credo che di Giorgio Gaber e del Teatro-Canzone non si potrà mai fare a meno.
Giorgio Gaberscik nasce a Milano il 25 gennaio 1939; la famiglia, della media-piccola borghesia, si trasferisce dal Veneto in Lombardia in cerca di fortuna: curiosa è l’origine del cognome, in quanto gaber è un termine slavo che vuol dire “carpino”, cioè albero della famiglia delle betullacee, alberi di cui doveva essere ricca la regione di provenienza. A otto-nove anni ha un infortunio che lo costringe ad una rieducazione alla mano sinistra e quale migliore strumento della chitarra può utilizzare, copiando il fratello maggiore?
Ed ecco la passione per Barney Kessel, Tal Farlow e Billy Baner e per l’italiano Franco Cerri, che va ad ascoltare alla Taverna Messicana. Inizia quindi a suonare in vari gruppi, tra musica leggera e jazz, e gli artisti con cui si esibisce sono tanti: da Giugo Agosti ad Adriano Celentano, da Enzo Iannacci a Luigi Tenco. Nel frattempo, si è diplomato ragioniere e la stessa estate dopo il diploma comincia a cantare, cosa che lo avrebbe aiutato a mantenersi alla Bocconi, fin quando viene notato da Nanni Ricordi, che lo lancia nel mondo dello spettacolo con la canzone Ciao ti dirò, uno dei primi brani rock in italiano, che lo fa conoscere al pubblico con la sua prima esibizione in tv alla trasmissione Il Musichiere condotta da Mario Riva nel 1959. E comincia la sua carriera anche come melodista e paroliere, e la sua Non arrossire del 1960 (scritto con Maria Monti a lei legato anche sentimentalmente) è il primo grande successo, a cui segue Trani a gogò (1962), Goganga e Porta Romana (1963).
Comincia ad appassionarsi anche alla canzone francese, riconoscendo ad essa uno spessore culturale che invece manca alla musica leggera italiana e il suo primo maestro è Jacques Brel. Televisione, Sanremo, l’incontro e le nozze con Ombretta Colli, il Festival della Canzone Napoletana… e le sue famose canzoni Torpedo blu, Come è bella la città (primo tema sociale affrontato in una canzone), Il Riccardo, Barbera e champagne... sono alcune fasi della sua sempre più grande popolarità, ma arriva il 1970, un periodo così ricco di avvenimenti anche politici che lo mettono di fronte ad una nuova realtà, un po’ squallida nel fare televisione ma più qualificante nel fare teatro, una scelta, anche se meno remunerativa, che lo diverte e gli consente di essere a confronto con il pubblico.
Aveva conosciuto casualmente qualche anno prima Sandro Luporini, un esponente del Realismo Esistenziale, insieme ad un gruppo di pittori dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e poi della Metacosa, movimento artistico che univa un’incredibile intensità poetica ad una ricerca pittorica precisa e calcolata.
Con lui aveva scritto Così felice e Barbera e champagne, e decidono assieme di portare la canzone a teatro – e da qui la nascita del genere del Teatro-Canzone – con il personaggio del Signor G, altri se non Giorgio Gaber e Sandro Luporini o l’uno o l’altro. Ed allora ecco che come per magia si realizzano spettacoli speciali con canzoni, monologhi, racconti che grazie anche alla sua nuova casa discografica Carosello vengono trasformati in album. Gli spettacoli erano almeno di due ore, il tempo per sbloccarsi di fronte al pubblico, all’inizio erano le canzoni, poi piano piano alcuni interventi parlati (“io non sono ancora un attore”)… poi monologhi con cui affrontare temi dei più svariati. E l’estate Gaber e Luporini la trascorrevano a Viareggio per scrivere i testi dello spettacolo che sarebbe andato in scena la stagione successiva, Giorgio e Sandro i testi e poi Gaber la musica.
Ma chi è il Signor G? Il Signor G è un uomo adulto che vuole dialogare con i giovani, tema dominante del suo teatro, della sua voglia di confronto dei temi sociali e politici, spesso in controtendenza con quella che è l’opinione corrente, e la sua diviene via via una forma di comunicazione sempre più aggressiva, lanciandosi contro l’ipocrisia e la falsa coscienza delle persone: Lo Shampoo e Libertà è partecipazione sono alcuni esempi di quanto riescano Gaber e Luporini a prendere le distanze da moralisti ed intellettuali, forti di quella trasgressione che così tanto interessa i giovani.
Ma parla anche di come è difficile convivere con il quotidiano, di essere una cosa e non poterlo invece manifestare: argomenti che piacciono e il passaparola dei suoi spettacoli arriva a coinvolgere migliaia di spettatori con oltre cento repliche sia con il Signor G sia con il Dialogo e con Far finta di essere sani, ed ecco che Gaber comincia a prendere le distanze dal pubblico impegnato di sinistra. Sulla spinta del dubbio che il bisogno di cambiamento avvertito in quegli anni si stia dissolvendo in una sorta di moda o di atteggiamento di comodo nasce Anche per oggi non si vola, il cui titolo si deve a Luporini e ad un amico che gli diceva quella frase quando lo vedeva arrivare nel suo negozio di colori con un’aria particolarmente assorta.
Dopo Giorgio Gaber-Recital, spettacolo antologico dove presenta il meglio del suo Teatro-Canzone, nasce Libertà obbligatoria – per la prima volta Gaber si esibisce suonando la chitarra – il cui tema è il rapporto tra l’individuo e il sistema, che lo porterà poi a raccontare in altri spettacoli anche del rapporto tra l’individuo e il proprio corpo (anch’esso influenzato dal sistema capitalistico) e poi Polli d’allevamento (La festa, Quando è moda è moda), spettacolo in cui Gaber-Luporini sentono per la prima volta svanire quella spinta al cambiamento degli anni precedenti, ed esprimono tutta la delusione dell’inutile lotta contro un sistema che vuole rimanere omologato: qui dal “noi” si passa al “voi” quando Gaber e Luporini si rivolgono alla propria generazione e da qui nascono le prime tensioni e i primi dissensi specie da chi aveva tentato di tenere sotto controllo l’uragano mediatico scatenato dal Teatro-Canzone…
Con Io se fossi Dio Gaber si consacra come libero pensatore, come uomo che non ne può più della politica e incarna i disagi e la rabbia di tanti italiani e riproporrà questa canzone anche in Anni affollati, spettacolo più colto e in cui si avverte la rottura definitiva con il periodo precedente, con monologhi più divertenti (La masturbazione, L’anarchico), ma anche più disperati (Il porcellino); e poi Io se fossi Gaber, con l’appiattimento e la massificazione, Parlami d’amore Mariù, un’indagine sui sentimenti…
In questi anni Gaber si cimenta anche come regista teatrale in alcuni spettacoli la cui protagonista è la moglie Ombretta Colli, ma arriviamo a Il Grigio, lungo monologo pubblicato anche su disco, storia di un topo che si ritira da un mondo che non gli piace, va a vivere in una casa isolata e lì deve fare i conti con tutta la sua vita, le sue ansie, è costretto a fare una continua autoanalisi, a entrare in sé stesso per guardarsi, per fare un bilancio. “Quando l’uomo sprofonda nell’osservazione del sé, poi, riemerge, lentamente. È come la calma dopo la tempesta, si accetta. Tutto qui. Accettarsi”: con questo spettacolo Gaber fa una piccola pausa dal Teatro-Canzone, in quanto si tratta di uno spettacolo di prosa con un unico protagonista sul palco.
Siamo già negli anni Novanta: ci saranno tre stagioni per Il Grigio e poi Gaber ritorna a cantare in teatro e sempre con l’amico Luporini mette in scena uno spettacolo antologico, intitolato Il Teatro Canzone, che ripercorre tutta la storia dei vent’anni precedenti. L’unico inedito è il monologo Qualcuno era comunista, lucida analisi di quello che il comunismo aveva significato per tante persone, in termini di speranze ma anche di illusioni, e di quello che la fine di quell’esperienza ha voluto dire per molti. Con E pensare che c’era il pensiero Gaber riprende ad analizzare la realtà sociale con nuove canzoni come Destra-Sinistra, Quando sarò capace d’amare e Mi fa male il mondo e nuovi monologhi come La sedia da spostare, L’equazione e Sogno in due tempi.
Un’idiozia conquistata a fatica, critica della società degli anni Novanta, è l’ultima opera (l’undicesima) del Teatro-Canzone della coppia Gaber-Luporini: andrà in scena per tre anni, ma l’ultima stagione termina prima a causa delle condizioni di salute di Giorgio Gaber; la sua Il conformista sarà poi ripresa in una versione personalizzata da Adriano Celentano. E arriviamo al 2001: l’ultimo album è La mia generazione ha perso il cui brano più significativo è La razza in estinzione, e poi la partecipazione a due puntate del programma 125 milioni di caz...te, di e con il vecchio amico Adriano Celentano che con anche Antonio Albanese, Dario Fo ed Enzo Iannacci, giocando ad una surreale partita a carte, cantano insieme Ho visto un re.
Nonostante la malattia, questo ultimo successo televisivo lo spinge a preparare l’ultimo disco che purtroppo non sarà pubblicato se non dopo la sua morte avvenuta il 1° gennaio 2003: Io non mi sento italiano. Ecco qui il Teatro-Canzone: Giorgio Gaber, un uomo che sul palco riusciva con la sua musica, i suoi movimenti, la sua mimica a trasmettere tutto quello che con Sandro Luporini ideava sul mondo, sulla società, in un dialogo che cercava arrivasse fino in fondo al cuore di tutti quelli che lo ascoltavano, creando quel “filo” con il pubblico che lo seguì fino alla fine e che ancora oggi è felice di partecipare a ogni evento che faccia rivivere la voglia di comunicare di questi grandi artisti.
Sono stati tanti gli artisti che hanno portato in scena opere su Gaber, come Enzo Iachetti che con Chiedo scusa a Gaber ha voluto omaggiare Giorgio Gaber “manipolando” i suoi classici più famosi, e Luca Martella, un attore che approfittando della sua straordinaria somiglianza con Giorgio Gaber in quasi 10 anni ha portato in scena spettacoli utilizzando talvolta immagini delle opere pittoriche di Sandro Luporini, concesse a Martella da Adriano Primo Baldi, manager del grande artista amico di Giorgio Gaber, dell’ADAC di Modena.
«… no, non muovetevi
c’è un’aria stranamente tesa
e un gran bisogno di silenzio
siamo tutti in attesa…»
Gennaio 2024 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.