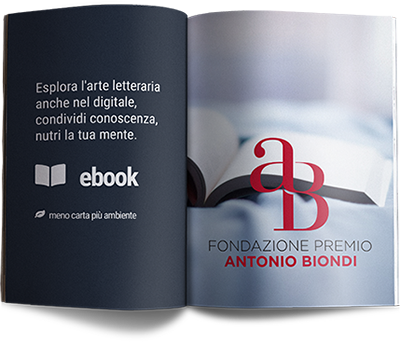EDITORIALE DELLA FONDAZIONE
C’è ancora domani
Basta un niente per tornare indietro nel tempo… magari un film!
Erano anni che non uscivo da un cinema con una sensazione di estrema soddisfazione, non tanto per il film appena visto, ma per le emozioni suscitate non solo in me ma anche in tante altre persone che ho notato fuori della sala.
Parlo di C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, sua opera prima nella regia e stupenda protagonista nella parte di Delia, un film particolare, imprevedibile, sorprendente.
In sala dallo scorso 26 ottobre, ad oggi ha già raccolto una serie di record, grazie al fortissimo appoggio dei media e dell’opinione pubblica che gli ha dato un’eccezionale risonanza mediatica: la prima posizione del box office nel weekend di uscita nelle sale, con un incasso di 1,6 milioni di euro che lo ha fatto diventare il film italiano con il miglior esordio del 2023.
Nell’ultimo fine settimana di novembre il film ha incassato 23.908.728 euro, terzo maggior incasso dell’anno, secondo maggior incasso stagionale nonché il più alto incasso per un film italiano degli ultimi tre anni e, sempre nello stesso periodo, è al 32º posto dei film con maggiori incassi in Italia di sempre.
Ma anche come riconoscimenti ad oggi si è fatto valere: alla Festa del Cinema di Roma 2023 ha vinto il Premio Concorso Progressive Cinema - Premio speciale della Giuria, il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas - Menzione speciale e infine il Premio del Pubblico.
Poche informazioni erano d’obbligo, ma non è di questo che mi piace parlare: preferisco non “spoilerare” (termine orrendo ma più comprensibile oggi ai più giovani) il film, proprio per non “rovinarne” la visione, anche se, a detta di alcuni critici ed esperti, ha sicuramente delle pecche.
Mi piace pensare al racconto di un pezzo di storia che tutti noi di riflesso abbiamo vissuto, nelle storie dei nostri genitori, dei nostri nonni: Paola Cortellesi parla di una Roma del 1946, di un quartiere popolare come Testaccio, con le Jeep degli americani ancora in giro per le strade di Roma, della vita vissuta in comune nei grandi cortili di una volta dove tutti vivevano tutto e insieme, nel bene e nel male.
Delia/Paola Cortellesi è il prototipo della donna appena uscita dalla guerra, non solo casalinga ma anche donna che lavora, correndo per negozi e per case (era infermiera, sarta, aggiustatrice di ombrelli) per racimolare quei soldi in più da portare a casa per arrivare, con quelli del marito e della figlia, alla fine del mese.
Il marito Ivano/Valerio Mastandrea (un grande attore in un ruolo per lui anomalo) è il padre padrone, più interessato ai suoi interessi che a quelli della famiglia, giustificato in tutto e per tutto perché “ha combattuto due guerre”, che dopo il lavoro va a giocare con gli amici oppure a divertirsi “con le donnacce” facendosi addirittura aiutare a vestirsi da Delia che come tocco finale gli deve spruzzare il profumo…
Sembra una vita tranquilla se non fosse che Marcella/Romana Maggiora Vergano, la figlia, non può continuare a studiare perché è il maschio quello a cui spetta andare a scuola, lei deve solo trovare un buon partito perché una volta sposata deve rimanere a casa e farsi mantenere, mentre ora deve lavorare per contribuire alle spese della famiglia; che il suocero di Delia, Sor Ottorino/Giorgio Colangeli, è un dispotico che si fa servire e riverire; che i due figli minori sono sempre a litigare e a dire parolacce… e poi…
E poi basta un nulla per scatenare la violenza di Ivano sulla moglie, che accetta supinamente perché è giusto che la moglie accetti e subisca ogni prepotenza.
Non voglio parlare di altro, perché per me il film è “imprevedibile”, lo stai guardando e pensi a quale possa essere il passo successivo e poi invece succede tutt’altro: bisogna viverlo momento per momento per capire quale era all’epoca la vita delle donne, e allora vogliamo parlare di femminismo, vogliamo parlare di violenza, vogliamo parlare di disparità anche economica, vogliamo parlare del patriarcato, dell’ignoranza che regnava sovrana… c’è tutto in questo film, tutto quello per cui le donne delle nostre famiglie hanno lottato per conquistare quel posto nella società di oggi che purtroppo ancora non è stato completamente ottenuto.
Ed ecco perché voglio parlare soprattutto dei ricordi che sono riaffiorati, delle storie che ci hanno raccontato le nostre madri, le nostre nonne: io posso dire di essere stata molto fortunata, mia madre era figlia unica ed ha potuto studiare ma solo fino al terzo anno delle Superiori perché poi mio nonno la fece ritirare dalla scuola perché la classe era diventata mista e lei con i ragazzi non doveva studiare, ma non ho mai visto atti di violenza nella mia famiglia, bastava uno sguardo per “farci rigare dritto”.
E ricordo mia nonna che “faceva la cresta”, come si dice qui a Roma, sulla spesa per mettere da parte qualche soldo non per sé stessa ma per investire in qualche oggetto d’oro che comprava da una signora che lo riscattava al Banco dei Pegni “sia mai un domani servisse di comprare qualcosa”, come il corredo per noi.
Mia nonna era la donna che aveva vissuto la guerra da sola con una figlia piccola, perché mio nonno per un periodo era stato dato per disperso, ed era stata fortunata a trovare lavoro come ricamatrice all’Unione Militare, lei che aveva fatto l’Ottava e quindi era riconosciuta come una donna che aveva studiato.
Ma non sono stata la sola a ricordare episodi della mia infanzia: tanti sono stati riportati indietro nel tempo, ricordando storie diverse, in cui effettivamente quella violenza così abilmente descritta nel film era accettata e subìta perché quella era la realtà di tutte le donne, prima figlie e poi mogli.
Così è stato anche per Diana, una delle amiche con cui ho condiviso la visione del film (una splendida cinquantenne e dico l’età solo per una collocazione temporale della sua storia, molto distante sia da oggi sia dal fine guerra): si è sentita toccata perché anche in lei sono riemersi tanti ricordi di quando era piccola, “tanti da scriverci un libro”, mi ha detto mentre parlavamo, con i racconti di sua madre, ultima di 6 figli e perciò anche la più fortunata perché gli altri fratelli e sorelle già se ne erano andati da casa e quindi per lei c’erano state meno restrizioni.
Diana sapeva che suo nonno a 40 anni non lavorava più e prendeva la pensione perché aveva “combattuto in guerra”, pensione di cui la famiglia non aveva mai usufruito (non hanno mai saputo che fine facessero quei soldi!) e per cui aveva costretto la nonna ad andare a lavorare, ad accudire la casa e i 6 figli ed a prendersi anche tutte le colpe con conseguenti “botte” se il marito trovava da ridire su qualche mancanza.
Le raccontò di quando a 18 anni, pazzamente innamorata di un ragazzo, chiese al padre il consenso per andare ad una festa ed invece scappò di casa e fu la madre ad essere accusata di esserne la complice e a subire le percosse dal marito… lei non ne sapeva davvero nulla, al momento della fuga era al lavoro, ma subì ugualmente la violenza.
Se agli occhi di tutti, figli ed amici, era un uomo severo ma buono, pulito, tranquillo, nascondendo la sua violenza a tutti e riservando i suoi sfoghi solo alla moglie, ci furono degli episodi che fecero capire a Diana, sin da piccola, che “uomo cattivo” in realtà fosse suo nonno: un giorno lei, piccolina, aveva convinto la nonna a comprarle una corda per saltare, ne era così felice e si meravigliò quando la nonna vide da lontano il marito, le prese di mano la corda e la nascose sotto la giacchetta che portava; alla domanda: “Ma che nonno non voleva che tu mi comprassi la corda?”, lei rispose “No, no… è meglio però non fargliela vedere!”.
Oppure quando chiedeva ai nipoti se volevano un gelato o una caramella ma poi, dispiaciuto, diceva “Peccato! Non ho portato dietro i soldi”… e succedeva sempre così!
Ma la cosa più brutta era che agli occhi di tutti era alla fine la nonna la tiranna, quella che, costretta da lui quando erano soli a rimproverarli per le classiche marachelle da bambini altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze, veniva poi redarguita sempre da lui con la solita frase “Ma che fai, povere creature, lasciali fare!!!”.
Ne avrei ancora tante di storie da raccontare, belle e brutte, spronata dalla visione di un gran bel film…
Credo che se avessi un blog inviterei tutti a raccontare le loro storie, ma più che altro le emozioni delle vite vissute tramite i ricordi di grandi donne che posso dire, con certezza, hanno fatto, chi più chi meno, la nostra storia!
Maria Teresa Protto
Novembre 2023 © Maria Teresa Protto

Fondazione Premio Antonio Biondi
Via Garibaldi 34
03017 Morolo (FR)
Fondazione terzo settore
C.F. 92088700601
segreteria@
IBAN:
IT18I0529714801CC1030072196
BIC: BPFRIT3FXXX
editoriale in collaborazione con
Centro studi su innovazione,
comunicazione ed etica.